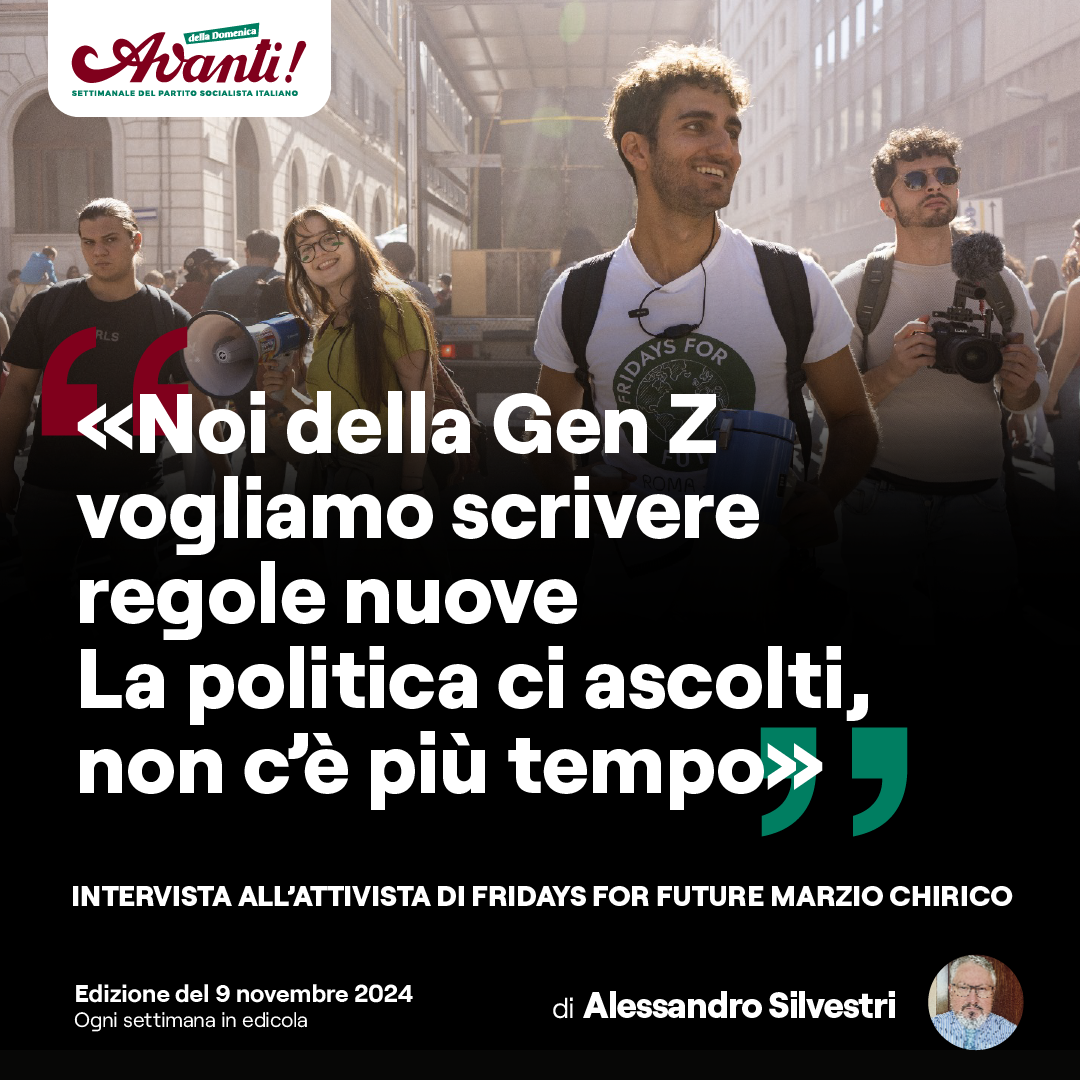di Alessandro Silvestri
La crisi climatica e le continue tragedie atmosferiche che accadono sempre più di frequente in mezza Europa e non solo, impongono un decisivo cambio di strategia politica ed economica a livello globale. Mentre i principali nemici dell’umanità e del pianeta pensano e architettano guerre e minacce anacronistiche in lungo e in largo. Doppiamente criminali, per l’oggi e per il furto di risorse per il futuro. Ne parliamo con Marzio Chirico, psicologo ventisettenne attivista di Fridays for Future, il movimento lanciato da Greta Thunberg nel 2018. Temi a noi particolarmente cari, che affondano le radici negli anni ‘80 quando i socialisti europei lanciarono la prima campagna mondiale sui temi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile. “Our Common Future” lo slogan del “Rapporto Brundtland” è oggi più che mai forte, vivo e necessario in noi, e per tutti noi.
La transizione ecologica ed energetica è oramai una battaglia globale ineludibile. Secondo te a che punto siamo con la transizione o meglio, la trasformazione culturale necessaria rispetto al tema?
«Bisogna resistere ad ogni assalto, in un momento in cui i soldi vanno alle guerre rispetto alla transizione energetica. L’esempio sono le ultime alluvioni. Fondi tagliati, soccorsi ritardati ma le destre, come a Valencia, resistono all’assunzione di responsabilità. Ci sarebbe da fare, comunque, una disamina socio-antropologica: le persone iniziano a vedere la crisi climatica sotto la suola delle scarpe, letteralmente, ma ancora non agiscono».
Perché?
«Differenze di sensibilità, di consapevolezza, tanta propaganda contraria. Quegli spazi, se non sono occupati con visione e radicalità, se li prende la reazione e il negazionismo climatico. Come in Sardegna, dove una buona fetta della popolazione è diventata contraria alle rinnovabili, o perlomeno ai parchi eolici e fotovoltaici, pure di piccole dimensioni. In generale, manca l’inquadramento, perché è un tema complesso, forse il più complesso. Ma è il sintomo che la trasformazione sociale sta procedendo come un elastico: per questo non bisogna mollare di un centimetro, sul livello locale e globale; sensibilizzazione, pressione politica, campagne. Facciamo tanto ma in una fase difficile, è necessario resistere e continuare a costruire comunità, come direbbe Bell Hooks.»
Il nucleare di ultima generazione potrebbe rientrare secondo voi di Fridays for Future, almeno come scelta transitoria, nel pacchetto di riconversione energetica necessario ad arrivare effettivamente ad emissioni a basso impatto?
«Parlare di nucleare di ultima generazione come scelta transitoria è un ossimoro. I nuovi reattori ordinati dalla nuclearissima Francia saranno pronti per il 2035- 2037 (fra 12-15 anni). Di tanto in tanto emergono dati su nuovi strabilianti progressi dell’ultima generazione, eppure è da anni che attendiamo. Servirà una quota a livello mondiale: siamo già vicini, per il nucleare, secondo i report dell’International Energy Agency e di IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ma dovremo avere il 90% di energia da rinnovabili al 2050. Bene la ricerca scientifica (anche in campo nucleare) sulla quale ci basiamo come Fridays for Future, dopodiché dobbiamo stare entro i target (già al ribasso) di decarbonizzazione del 2030 e 2050. Servirà accelerare la ricerca su tutti i settori a basso impatto. Cionondimeno, le rinnovabili e specialmente le comunità energetiche, se costruite dal basso, sono quella forma di impatto locale che contrasta la crisi climatica e crea solidarietà e azione sul territorio, contrastando la speculazione energetica e l’accumulo di capitale nelle mani di pochi: fra le cause della stessa crisi del clima e dell’ambiente. Il nucleare va in senso opposto ma necessita di molta acqua, altro bene collettivo a rischio. Continuiamo la ricerca ma ci serve altro a stretto giro.»
Ci vuoi parlare brevemente dei cinque punti d’azione individuati dalla vostra agenda climatica? Secondo te la classe dirigente politica ed economica è pronta ad affrontare le sfide necessarie o la stringente contingenza come il disastro di Valencia?
«Trasporto, lavoro, acqua, energia, edilizia. L’Agenda Climatica è nata dall’esigenza di mettere all’angolo la politica. Dentro ci potete trovare idee, proposte, dati e soprattutto la copertura economica per realizzare tali progetti. In questi anni in cui manca trasparenza sui fondi pubblici (Pnrr) andiamo contro corrente: marea verde che effettua una messa a terra delle principali necessità a livello italiano. Siamo indietro sul lavoro, specialmente sul tema dei lavori verdi e rinnovabili, sui trasporti (grottesca la situazione a Roma, specchio dell’Italia). Dagli anni ‘80 ad oggi abbiamo praticamente azzerato la produzione di bus (da 6 mila a 3 mila nel 2000, a poche centinaia oggi). Il rilancio pare lontano e fumoso. Perciò, stiamo collaborando con GKN, il collettivo di fabbrica che ha occupato lo stabilimento a Campi Bisenzio dopo la minaccia di licenziamento, alla campagna sui Climate Jobs: l’obiettivo è la reindustrializzazione della fabbrica per produrre pannelli fotovoltaici e cargo bike. Le energie rinnovabili generano tre volte i posti di lavoro dei combustibili fossili. La politica sta a pagina uno sui temi dell’edilizia – ricordiamo il bonus 110% destinato di fatto a villette e non a palazzine popolari col più alto tasso di dispersione energetica – e sulla siccità così come l’energia. Questa è un’agenda che prova a sviscerare tali temi con metodo e ambizione, alzando l’asticella. Asticella che la classe politica non si scomoda neanche a guardare dov’è, così lontana dal sentire di noi giovani di Generazione Z.»
La cosiddetta giustizia climatica indicata nelle vostre battaglie, è anche una domanda fortemente attualizzata di giustizia sociale?
«È complesso far passare questo concetto ai più. Dire che le popolazioni più colpite sono quelle che inquinano di meno e più subiscono gli effetti della crisi, significa parlare di giustizia climatica. Dire che l’1% delle persone più ricche al mondo inquina quanto e oltre il 50% delle persone più povere, è parlare di giustizia sociale. Giustizia climatica è giustizia sociale e viceversa. La transizione è un tavolo da gioco che va rovesciato: una parte continua a giocare con le solite regole, noi ne vogliamo scrivere di nuove. Il nostro pianeta è preso in prestito dalle generazioni future e tenere a mente questo è il concetto più alto di giustizia che l’essere umano possa concepire.»