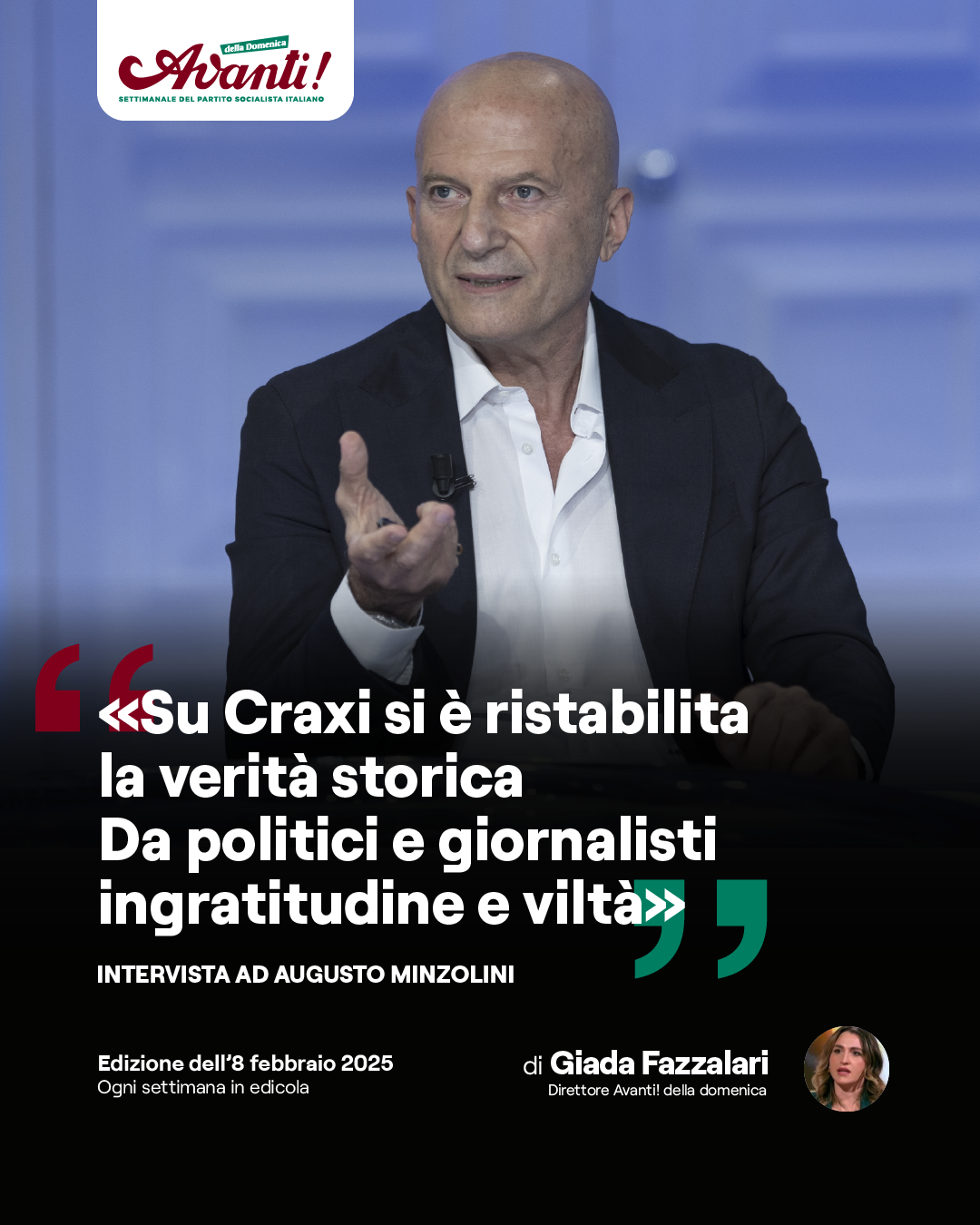di Giada Fazzalari
Di tutte le vite vissute da Augusto Minzolini – già direttore del Tg1, parlamentare, alla guida de Il Giornale ed editorialista per diverse testate – quella del cronista di strada, con la passione viscerale per la notizia ‘strappata’, è quella che gli calza meglio. Sul suo cognome si è persino creato un neologismo: «Il minzolinismo»: la capacità, cioè, di “rubare” la notizia e maneggiarla ad arte. Chiunque, nell’ambiente politico e del giornalismo parlamentare, gli riconosce di essere tra i più acuti retroscenisti degli ultimi trent’anni. Al tempo di Mani Pulite era un cronista che con Craxi aveva un rapporto “complicato ma leale” – ci dice in questa intervista. “Mi chiamava raccoglitore di cicche perché seguivo ogni pista per avere notizie. Con il tempo si è instaurato un rapporto di fiducia”. Minzolini è stato spesso, nei suoi quarant’anni di carriera giornalistica, al centro di polemiche anche aspre. Sintomo, forse, che per essere giornalisti di qualità, bisogna anche avere un certo coraggio.
Direttore, lo scontro tra politica e magistratura è tornato a irrompere con forza nell’agenda politica nelle ultime settimane. Quando finirà questa “guerra dei trent’anni” che non fa bene a nessuno?
«Finirà probabilmente quando tornerà l’equilibrio dei poteri venuto meno da Tangentopoli in poi. Vedo che qualche partito, a cominciare da Forza Italia, ha proposto di reintrodurre l’immunità parlamentare. Un provvedimento di cui io sono convinto da sempre. È stato un errore togliere una norma che di fatto creava le condizioni per un’autonomia della politica rispetto alla magistratura. La conseguenza è stata che nell’architettura costituzionale il quadro non è stato più armonico e si sono create le condizioni in cui anche delle decisioni squisitamente politiche rischiano di diventare oggetto di iniziative giudiziarie».
Se è vero che la magistratura non deve entrare nelle questioni politiche, è vero anche che cercare uno scontro frontale con i giudici rischia di rompere quell’equilibrio di cui parlavi tu e di pesare sulla qualità della democrazia, come è stato nel caso del generale libico.
«Nel caso Almasri la via maestra sarebbe stata quella di apporre subito il segreto di Stato per motivi di sicurezza nazionale, come ragione per rimpatriarlo. Ora, invece, quando bisogna dire l’indicibile, è difficile venirne fuori. Bisogna però dire che si tratta di un personaggio con cui questo Paese ha a che fare da dieci anni, dal 2015 in poi, per cui con tutti i governi che si sono succeduti da allora».
Sono venticinque anni dalla scomparsa di Craxi. Molti, compresi i suoi detrattori, lo hanno celebrato con una sorta di riscoperta collettiva. La distanza dagli eventi aiuta a vederli con più lucidità e oggettività?
«Sicuramente c’è stata una riscoperta anche alla luce di quello che è diventato questo Paese, specie nelle sue classi dirigenti, spesso è caratterizzato da un atteggiamento pusillanime, ignavo e ipocrita. Io non ho avuto bisogno di venticinque anni per riscoprirlo, perché sono tra coloro che capirono la statura del personaggio e la portata degli eventi che lo portarono all’epilogo che conosciamo».
Hai realizzato, non senza polemiche, la prima intervista televisiva che Craxi rilasciò dall’esilio ad Hammamet…
«Si è così. Per dare l’idea di come fosse all’epoca la situazione, nonostante il valore giornalistico di quella intervista fosse chiaro a tutti, il giorno dopo ci fu un talk show in cui tentarono di processarmi, perché avevo intervistato “un latitante”».
Torniamo a Tangentopoli. Furono spazzati via i partiti tradizionali per lasciare il campo alla stagione del populismo. Non si può dire insomma che poi andò meglio…
«Nel momento in cui è venuta meno la politica sono stati privilegiati l’atteggiamento populista e gli estremismi, sottraendo la prerogativa dei partiti storici, cioè la logica che sovrintendeva alla loro politica, cioè mediazione e il compromesso. E in più è arrivato il bipolarismo che non ha aiutato».
Dove furono gli errori?
«Ce ne furono molti e da molte parti, ma vennero soprattutto dall’allora Pci. Craxi fece una politica autonomista. Dopo il crollo del muro di Berlino, tentò di creare le condizioni per una sinistra riformista e socialista in questo Paese, ma non ci riuscì. E probabilmente, sembrerà strano, pagò anche la sua generosità. Se fossimo andati a elezioni nel ’91, cosa che gli scongiurò di non fare Occhetto, non si sarebbero create le condizioni che portarono a Tangentopoli. Un anno dopo i suoi avversari, malgrado avesse dato l’assenso a farli entrare nell’Internazionale socialista, furono spietati con lui, lo considerarono come il padre di tutti i mali».
Perché la giustizia dunque si accanì su Craxi?
«Perché era l’asse portante dell’equilibrio di allora. Dei reati che furono ravvisati nell’azione dei partiti, di tutti i partiti, ci fu un maggior accanimento con Craxi perché essendo quell’inchiesta molto politica, individuarono in lui l’elemento forte, caduto il quale, probabilmente, sarebbe crollato il sistema. Cosa che avvenne».
Probabilmente anche perché Craxi era stato protagonista di grandi cambiamenti nella società di allora.
«Aveva portato una ventata di modernità. Era una cosa su cui doveva riflettere l’intera sinistra e invece fu criminalizzato. E le criminalizzazioni, lo abbiamo visto con Craxi, con Berlusconi ma anche con Renzi, non portano da nessuna parte e non aiutano neanche chi le utilizza. Si è creato nel tempo un meccanismo perverso in cui invece di creare un bipolarismo di realtà competitive ma non nemiche, si sono prodotti solo nemici da criminalizzare. Quando si utilizza la giustizia come arma politica, si creano nemici e non avversari. Un errore».
Il ruolo della stampa dell’epoca, presa dal furore del popolo, è stato discutibile. Ora qualcuno fa mea culpa. Un po’ tardi?
«Quando parlavo di ignavi e ipocriti, mi riferivo anche a certa stampa. Io mi sono ribellato immediatamente a quel tipo di narrazione».
E tu che rapporto hai avuto con Craxi?
«Un rapporto un po’ complicato ma corretto. All’inizio mi chiamava “raccoglitore di cicche” perché ero sempre tra i piedi per cercare di raccogliere le notizie e i retroscena che potevo. Poi una volta feci un pezzo in cui dicevo che per fare carriera in Rai, dovevi frequentare il salotto di Ania Pieroni. Successe un putiferio. Lui fece in modo che io non potessi andare al congresso del Psi per seguirlo».
Come finì?
«Il giornale per cui lavoravo, non certo ‘cuor di leone’ (sorride…), siccome Craxi era contrariato, si inventò che dovevo andare al congresso dei Radicali che si teneva a Rimini in contemporanea a quello socialista».
E raccogliendo le cicche, che impressioni avevi?
«Facendo il cronista, per strada, mi ritrovai sulla scena delle monetine e ammetto che quella vicenda mi cambiò. Di fronte a quella scena capisci cosa sia il giustizialismo e come lo strumento giudiziario usato in maniera perversa, quindi politicamente, abbia pesato sulla storia di questo Paese».
Con il tempo il vostro rapporto migliorò?
«Sì, perché aveva capito che ero leale, nonostante non la pensassimo allo stesso modo su molte cose. Si era creato un rapporto di fiducia. Altri ne trassero profitto. Craxi contava sia in Rai, sia in Mediaset che nei giornali. E ci fu un voltafaccia di molti giornalisti dettato dalla paura. Io credo che Craxi ci rimase male, perché venne soprattutto da chi lo conosceva bene».
Un fatto che rimase sotto traccia.
«Sì. Anche se tutti avevano la sensazione che ci fosse stata una grande ingiustizia. Dopo un quarto di secolo siamo ritornati ad avere un atteggiamento un po’ più oggettivo della vicenda. Molti si rendono conto che molto di quello che fu fatto allora fu un errore, sia da parte della politica, che fu vile, ma anche da parte dei mezzi di informazione. Nessuno ebbe il coraggio di mettersi controvento».
Che sensazione traevi del personaggio, quando lo intervistavi nel periodo in cui era iniziato il declino?
«Era capace di una chiarezza esemplare nella interpretazione dei meccanismi politici e della storia del Paese. Credo che fosse, nella classe dirigente di allora, l’unico che fu consapevole di quale sarebbe stato l’epilogo tragico di quel periodo. Venuto meno lui, sarebbe stato travolto l’intero sistema. Ci hanno messo venticinque anni per riconoscerne la statura».
Cosa significa questo?
«Significa che siamo un Paese ingrato, ma anche miope, perché ripetiamo spesso questi meccanismi: creiamo patiboli per poi pentircene. Aver dimenticato i meriti di Craxi, considerandolo soltanto un delinquente, non è stato solo un delitto, è stato un peccato mortale per tutti quelli che si sono occupati e hanno scritto di politica in quegli anni».
Fece rumore quella intervista alla pizzeria Fiammetta nel dicembre del ’93 che realizzasti per “La Stampa”. Vale la pena di ricordarla…
«Parole che trasferivano una certa tragicità del momento. Craxi può essere definito un eroe della tragedia greca. Da animale politico aveva capito tutto. Disse più o meno così: “Anche da morto farei dei buchi alla bara per gridare la verità. Io parlo e continuerò a parlare”. È quello che è successo. Da morto è riuscito a ristabilire almeno la verità storica».