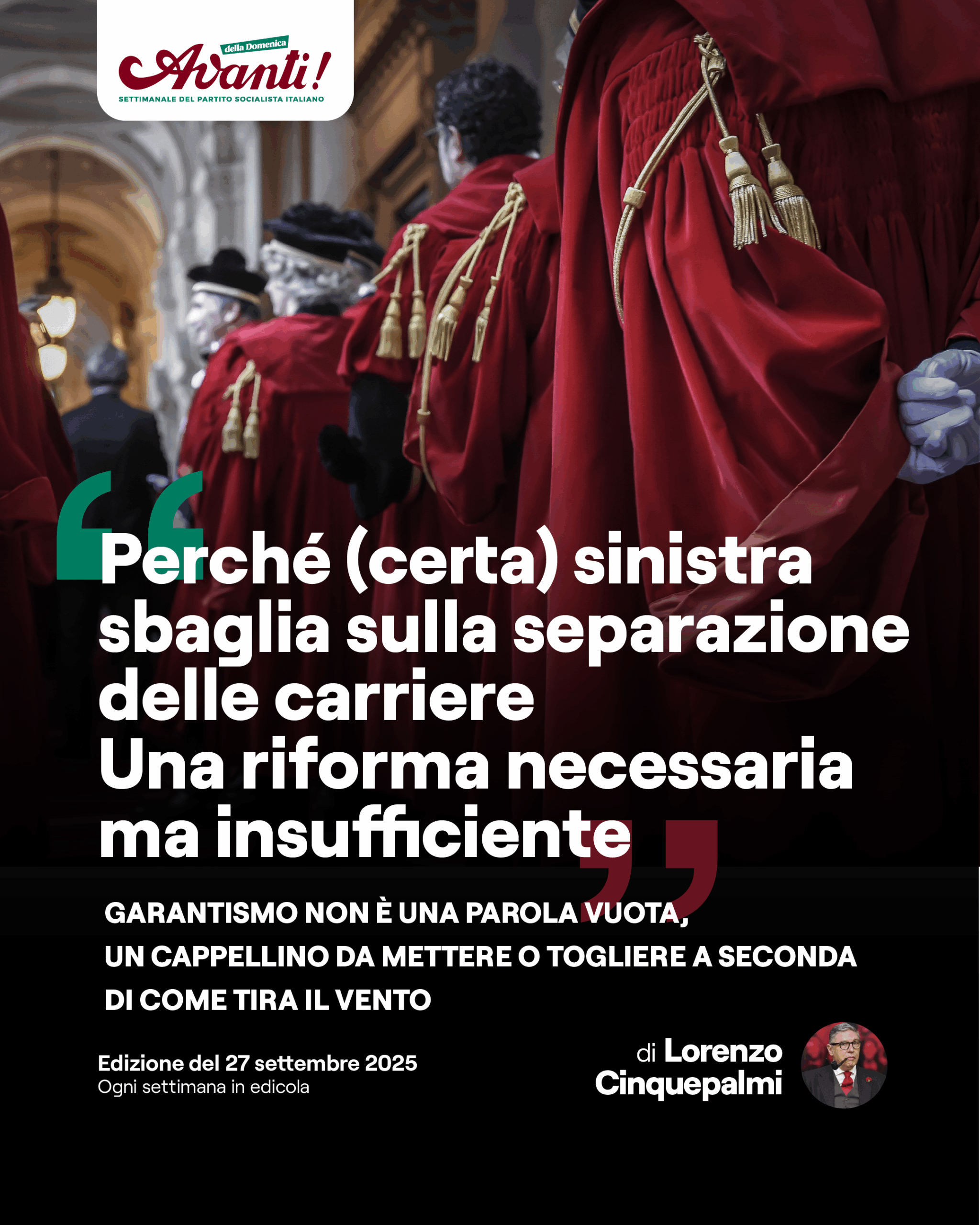di Lorenzo Cinquepalmi
Il disegno di legge costituzionale che ha passato la terza lettura parlamentare nei giorni scorsi, introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti: diversi i concorsi con cui si accede alle due diverse magistrature, escluso ogni transito dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. La riforma prevede una modifica sostanziale della disciplina costituzionale dell’ordinamento giudiziario, con l’istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura, ferme le garanzie di indipendenza delle due magistrature, giudicante e requirente, oltre al trasferimento della competenza per i giudizi disciplinari dei magistrati di entrambe le carriere, oggi in capo al CSM, ad una Alta Corte disciplinare comune per le due categorie. Il testo interviene a modificare gli articoli fondamentali della Costituzione sul ruolo della magistratura (gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110); il Presidente della Repubblica è il presidente di entrambi i Consigli Superiori, come oggi lo è dell’unico esistente (art. 87); le funzioni giudicante e requirente sono attribuite a differenti categorie di magistrati (art. 102) e le carriere di ciascuna categoria sono governate da due diversi CSM, la cui composizione non è più elettiva ma sorteggiata in elenchi per i membri laici e tra tutti i magistrati delle due diverse carriere per i membri togati (artt. 104 e 105); i concorsi di accesso sono differenziati (art. 106) ma restano garantite a tutti i magistrati di entrambe le carriere l’indipendenza e l’inamovibilità (art. 107), mentre, come s’è detto, il potere disciplinare è esercitato per entrambe le carriere da un’unica Alta Corte, la cui composizione è sempre affidata al sorteggio: sei componenti tra i giudicanti, tre tra i requirenti, tre da un elenco compilato dal Parlamento; gli ultimi tre membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. Il presidente dell’Alta Corte non può essere un togato e i giudizi saranno affidati a collegi formati da alcuni dei componenti, mentre le decisioni dell’organo potranno essere impugnate davanti all’organo stesso che affiderà in giudizio a un collegio formato da componenti diversi da quelli del collegio la cui decisione è stata impugnata. La riforma ha come unico oggetto la radicale separazione tra giudici e pubblici ministeri fin dal loro reclutamento, puntando a eliminare ogni punto di contatto tra i due ambienti, con l’istituzione di Consigli Superiori separati, lasciando come unica area comune la corte disciplinare. Dal punto di vista parlamentare, la maggioranza procede spedita verso l’approvazione a maggioranza semplice, come è avvenuto alla Camera dei Deputati nel primo passaggio della seconda lettura, ciò che schiude lo scenario del referendum confermativo. Infatti, nel caso in cui alla seconda lettura una legge costituzionale non ottenga la maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le camere, può essere richiesta l’indizione del referendum confermativo a richiesta di un quinto dei componenti di una delle camere stesse, o di cinque consigli regionali, o di 500.000 elettori. Il referendum confermativo è sempre valido, non essendo previsto un quorum. Dalle opposizioni parlamentari, e in particolare dal Pd, è partita, con l’annuncio della raccolta delle firme, la scommessa del referendum, con cui evidentemente si spera di infliggere una sconfitta alla maggioranza meloniana. Non si spiega altrimenti una posizione che registra incoerenze e incongruenze notevoli. La responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani, che in passato si era espressa a favore della separazione delle carriere, è arrivata a dichiarare che la riforma è “pericolosa per gli equilibri democratici del nostro Paese” e che “mina l’equilibrio tra poteri dello Stato e indebolisce le garanzie dei cittadini.”. Aggiunge che la separazione delle carriere, che fino a poco tempo fa auspicava, sarebbe “un attacco diretto all’indipendenza della magistratura e alla nostra democrazia.”. In disparte ogni considerazione sulla fermezza di principi che caratterizza la posizione nel tempo assunta dalla dichiarante, resta la perplessità sul merito, dato che non si spiega come il nuovo assetto possa, non solo attentare, ma anche semplicemente scalfire l’indipendenza della magistratura, dal momento che nessuna delle norme costituzionali che saranno modificate prevede una modificazione dell’attuale sistema di garanzie dettate a favore dei magistrati, che restano intangibili, inamovibili e, purtroppo, incensurabili tanto quanto lo sono oggi, sia che appartengano alla magistratura requirente sia che facciano parte della magistratura giudicante. Il mese scorso il giurista Gratteri, uomo davvero per tutti i riflettori, rispondendo a una domanda del giornalista Gianluigi Nuzzi sul Palamaragate, ha ammesso che “Siamo al 3ł per cento di consenso, la fiducia è dimezzata, ma ce lo meritiamo.”, riconoscendo ciò che è di comune percezione, ovvero che l’immenso patrimonio di credibilità e fiducia capitalizzato, e in parte usurpato, con “mani pulite”, è ormai disperso. Ma allora, politicamente ragionando, viene da chiedersi: se contrastare la separazione delle carriere è incoerente con le proprie posizioni passate; se non è vero che la riforma attenta all’indipendenza dei magistrati; se neppure il tornaconto elettorale è promettente, vista la scarsa fiducia che gli italiani ormai ripongono nei magistrati, allora cosa induce, verrebbe da dire costringe, il principale partito d’opposizione a imbarcarsi nel referendum? Che davvero esista un partito delle procure che tiene sotto scacco la maggior parte dell’attuale opposizione? Garantismo non è una parola vuota, un cappellino da mettere o togliere a seconda di come tira il vento; garantisti o lo si è davvero, e allora lo si è sempre, o non lo si è, e allora si suona falsi come una moneta da tre euro quando si afferma di esserlo. Essere garantisti significa difendere i principi di presunzione di non colpevolezza, dell’assoluta residualità della carcerazione preventiva, del “in dubio pro reo”; significa volere una società in cui la funzione giudiziaria sia tenuta ben lontana dal circo mediatico, in cui qualsiasi magistrato svolga la sua funzione senza timori di nessun genere, ben protetto dalla società, ma senza aspirazioni che possano interferire con la sua imparzialità. Basta la separazione delle carriere a realizzare tutto questo? No, evidentemente, ma è un passo necessario. Quella in discussione è una riforma che avrebbe dovuto essere proposta da una sinistra riformista, democratica, libertaria, garantista. In una parola, europea. Invece, chi dovrebbe rappresentare quella sinistra in Italia sta ingaggiando una battaglia di retroguardia in difesa degli interessi corporativi di quella magistratura militante che rappresenta solo una rumorosa e aggressiva minoranza dei magistrati italiani. Rischia di essere la vera cartina di tornasole su cui misurare la natura intima delle forze che dichiarano di essere di sinistra, perché quella sui limiti democratici e costituzionali del potere, di qualsiasi potere, compreso quello giudiziario, è una battaglia di libertà, e senza la pregiudiziale assoluta della difesa di tutte le libertà la sinistra non è sinistra. È qualcos’altro.