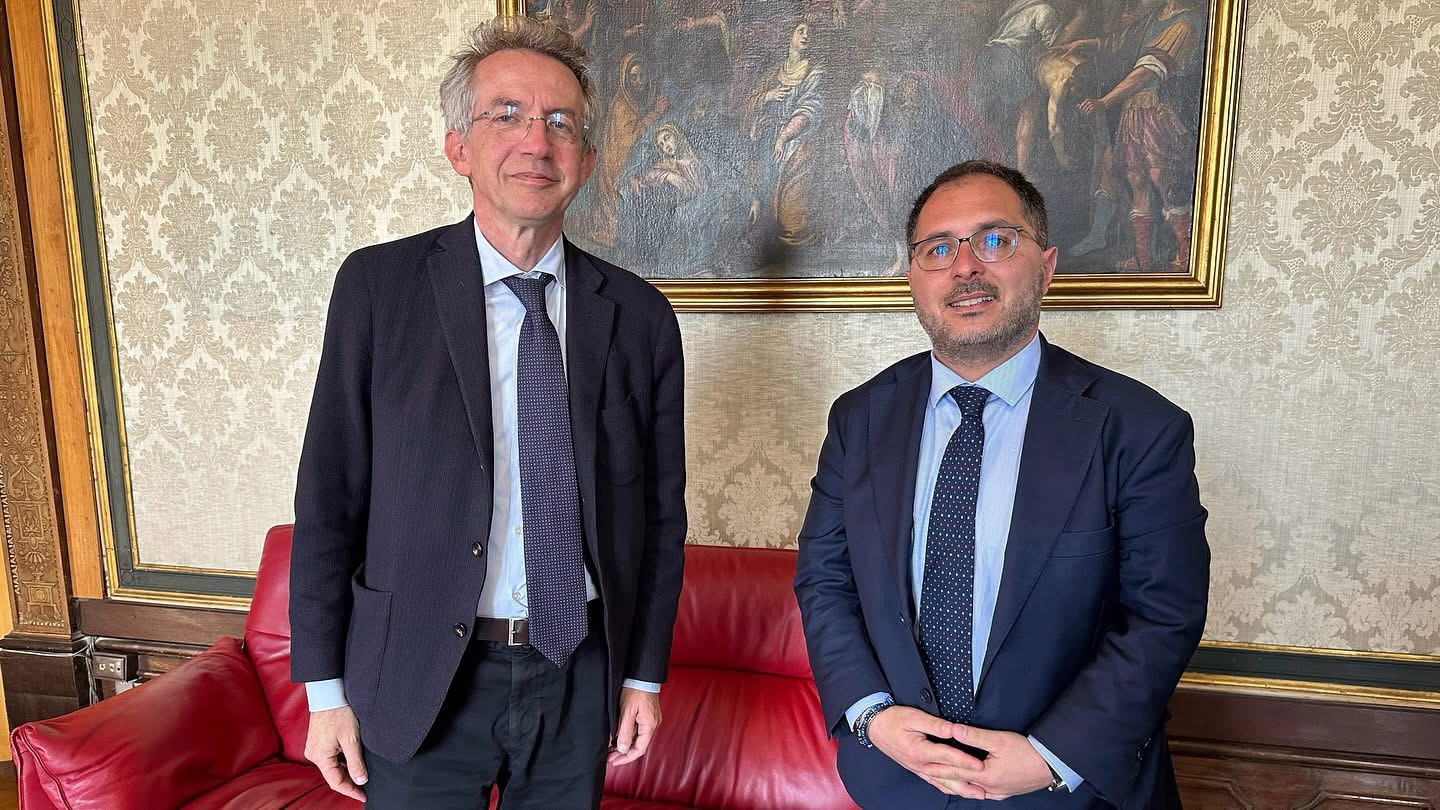di Lorenzo Cinquepalmi
La violenza politica costituisce un’inaccettabile aberrazione dell’ideale: nobili o esecrabili che siano le idee e l’organizzazione in cui si ha fede, il superamento del limite morale che vieta di spargere sangue conduce già in vita nel girone infernale del Flegetonte, che ti macchia la pelle rendendoti per sempre diverso dal resto dei tuoi simili. Il rimpianto per ciò che è stato e poteva non essere, per gli errori compiuti, per la miope buonafede con cui li si è compiuti, non ti lava il sangue di dosso. Alla fine, la tua pena non è quella che la giustizia ti ha irrogato, e che magari hai finito di scontare, ma quella che ti dai da te stesso, perché non riesci a perdonarti che in un certo momento, a un certo bivio, la vita, il destino, o la tua stessa superbia, ti hanno fatto imboccare la strada dell’inferno. Ecco, questo è quel che viene da pensare di Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, assassino, dissociato e pentito, a cui la sorte ha significativamente spento la mente anni prima della vita, a un’età in cui di solito si è ancora molto attivi. Consumato dal suo proprio destino, di cui è stato artefice, ha trascorso un quarto della sua vita in carcere, ha prima rivendicato e poi rinnegato la follia della lotta armata, ha odiato i compagni rimasti liberi, ha giocato con la verità legittimando il sospetto che certe sue rivelazioni fossero inquinate da una dose significativa di strumentalità. Il fatto è che per tutti coloro che passano attraverso questo fuoco, rossi o neri, politici o comuni, la verità non esiste, diventa un gioco. Non si può credere fino in fondo a ciò che Franceschini ha detto, scritto, tramandato, perché quando si è passato quel limite, ogni lealtà, ogni credibilità, ogni regola, sono perse per sempre. Il complottismo che si è divertito ad alimentare nella lettura di vicende che lo hanno visto protagonista o comunque consapevole, conferma la sensazione di avere a che fare con un personaggio rispetto al quale il discernimento tra falso e vero è diventato impossibile. Come per tanti altri, certamente macinati dalla storia per avere fatto scelte sbagliate, si può avere per Franceschini un sentimento di umana pietà, ma nessuna comprensione. Perché se è vero che sei rimasto preso nell’ingranaggio di una macchina molto più grande di te, di chi stava con te e di tutti noi, è altrettanto vero che senza un tuo atto di volontà l’ingranaggio non ti avrebbe potuto tirare dentro: eri lì e non hai fatto nulla per essere altrove. Del resto, il grande banco di prova che fu il sequestro Moro non ha visto Franceschini assumere il ruolo che avrebbe potuto intestarsi, perché l’occasione c’era. Il generoso tentativo di Craxi di trovare un canale di trattativa con le Br passa per Signorile, è vero, ma passa anche per Giannino Guido, che al tempo era l’avvocato proprio di Franceschini, il pezzo più grosso, insieme a Curcio, dei brigatisti detenuti. Eppure, quanto egli stesso ha raccontato una decina di anni fa in commissione stragi gli assegna un ruolo, in quei giorni convulsi del rapimento Moro, assai più modesto di quel che avrebbe potuto essere. In definitiva Franceschini muore come è vissuto: dalla parte sbagliata e con un marchio irredimibile di mediocrità che gli ha fatto scansare ogni tentazione di esprimere un lampo di grandezza, pur avendone l’occasione. Se ne va illacrimato: difficile immaginare, al di là, appunto, dell’umana pietà, che la sua parabola terrena possa ispirare un qualsiasi altro sentimento che non sia di indifferenza.