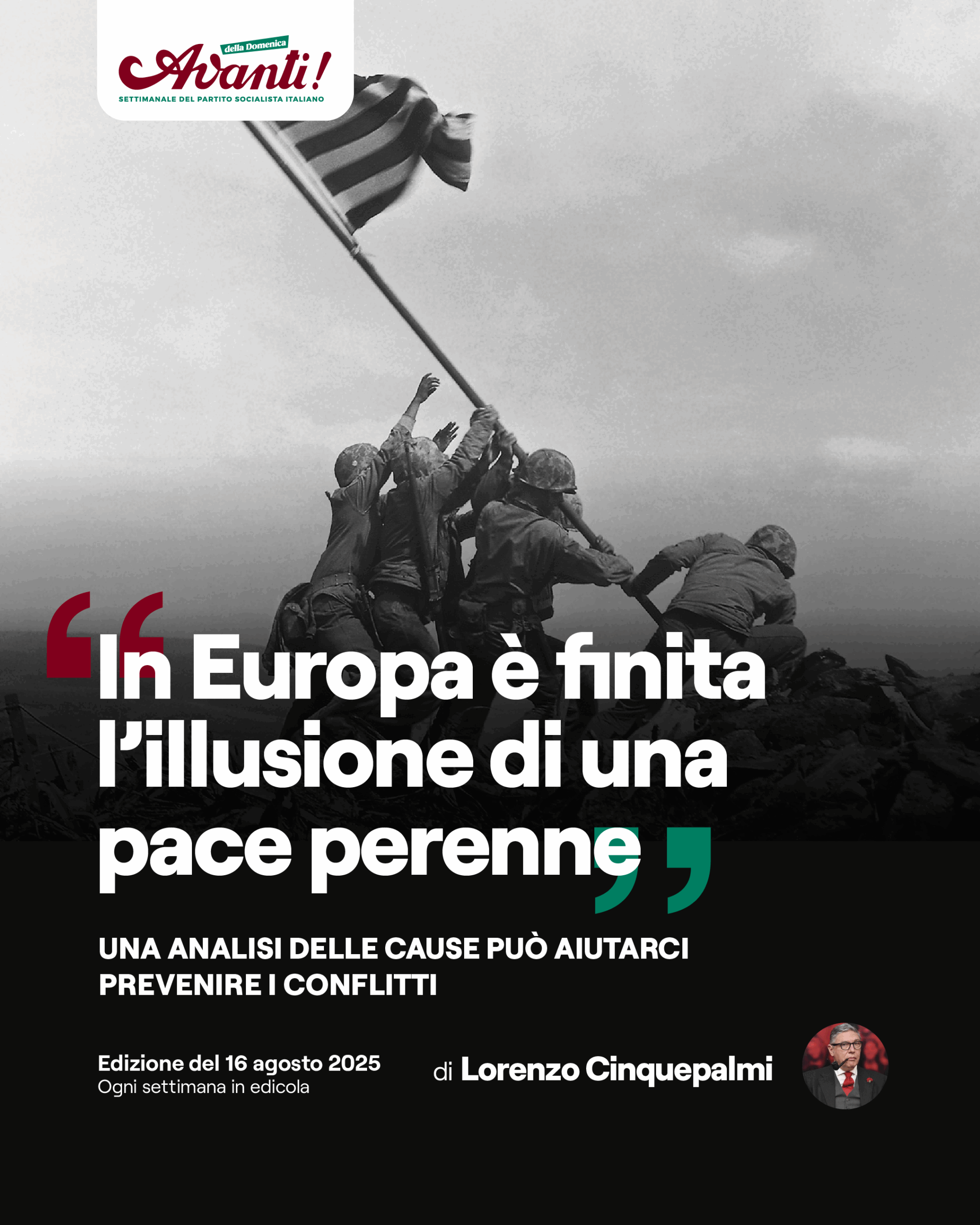di Lorenzo Cinquepalmi
Il tramonto di un ideale. Non è un fatto nuovo nella storia il doversi confrontare con i frantumi del sogno di aver posto fine al tempo delle guerre. Fu il sogno della belle epoque, e si infranse a Sarajevo. E fu la speranza di Wilson, della Società delle Nazioni, soffocata sul nascere dalla ferocia di dittature che dominarono la scena internazionale tra le due guerre mondiali. Perfino l’equilibrio della paura prodotto dalla lunga stagione della guerra fredda si tradusse nella duratura illusione che la sostanziale solidità di quella simmetria dall’aspetto precario fosse la garanzia di una pace mondiale o, meglio, della sempiterna fine delle guerre globali. L’illusione non è crollata di colpo, e se la caduta del muro di Berlino, seguita dal collasso sovietico, ha posto fine al sistema di contrappesi a fondamento di un’infinita pace armata, lo scenario degli anni ‘90 del novecento e dell’alba del terzo millennio, con la Cina non ancora così tigre, le altre potenze emergenti non ancora così potenze, la Russia infine nel G8, consentiva all’occidente di cullarsi nel miraggio della prosecuzione di un tempo in cui la guerra sarebbe rimasta ancora lontana dalla sua culla, quell’Europa da cui il mondo di allora era nato e che aveva scatenato le due guerre globali del ventesimo secolo. Indistruttibile appariva, soprattutto, l’asse atlantico tra Paesi europei e Stati Uniti d’America, cementato da un’ideologia comune, animata dalla dialettica tra conservazione e progresso, tra capitale e ceti del lavoro, tra visione tradizionale della società e frontiere sempre più avanzate dei diritti civili. Tutto questo è alle spalle. Sul terreno fragile di un’Europa finora incapace di farsi stato, prigioniera di miopie ed egoismi, e di uno scenario mondiale in cui la Cina è ormai una potenza prossima a superare anche gli Usa in termini di potere geopolitico reale, e in cui sono cresciuti tumultuosamente molti Paesi rimasti per troppi anni relegati nella landa di mezzo tra primo e terzo mondo, si è prodotto un evento che nessuno, in ottant’anni, aveva mai creduto possibile: la fine dell’asse atlantico tra Washington e i Paesi europei. Nessuno si illuda che la presidenza Trump sia una specie di varicella dopo il cui passaggio le cose possono tornare com’erano: niente sarà più come prima. Il trumpismo non è solo la causa del ritorno degli americani al loro isolazionismo genetico; è soprattutto il sintomo di un sentimento largamente diffuso nella popolazione statunitense, indotto dalla natura solipsistica di un sistema economico e sociale che non contempla forme di temperamento solidaristico alla ferocia del mercato. Le farneticazioni trumpiane sull’America derubata dagli amici non è un tentativo di condizionamento dell’opinione pubblica, ma semmai è un dar voce a convinzioni fortemente radicate, che per certi versi non sono lontane dal vero. Perché è innegabile che l’alleanza atlantica abbia sempre vissuto di un contributo militare sbilanciato, e anche che la competizione commerciale tra vecchio e nuovo mondo negli ultimi decenni abbia favorito il primo. Quel che manca a questa rappresentazione dei fatti è che l’America ha sempre trovato una contropartita nella costituzione di un blocco culturale con l’Europa, insieme alla quale costituiva un occidente storico e politico che ha nel vecchio continente un elemento indispensabile, senza il quale l’occidente stesso non è, mentre non è azzardato sostenere che senza Usa l’occidente può essere: basti vedere la posizione dei canadesi in proposito, col loro legame anche istituzionale col Regno Unito. Allora questo è il punto: l’indefettibilità dell’appartenenza a un modello occidentale, pur nelle differenze tra un’Europa fortemente intrisa di socialdemocrazia e un’America mercatista, è sempre stata, per le classi dirigenti statunitensi, una sorta di feticcio intangibile, considerando esse, in fondo, che la sensibilità verso la tutela dei meno fortunati fosse patrimonio comune, pur nella differenza dei mezzi con cui realizzarla. E questo ideale non era solo dei Roosevelt e dei Kennedy, ma anche dell’ala più illuminata dei repubblicani. La colpa della classe dirigente Usa sta proprio in questo: non essersi resa conto che il modello economico e sociale imposto dal turbocapitalismo finanziario negli ultimi venti anni avrebbe finito con l’allontanare l’opinione pubblica dal compromesso sociale raggiunto attraverso la palingenesi della grande depressione, l’esperienza della seconda guerra mondiale e la responsabilità del ruolo di garante mondiale delle libertà assunto al tempo della guerra fredda. Ma se Trump non è una varicella, allora dovrebbe risultare ai leader europei, o almeno ai più consapevoli di essi (quindi con esclusione di Meloni e di coloro che antepongono il tornaconto politico personale e di partito al destino di una civiltà) che non resta tempo da perdere per fare dell’Europa un soggetto della geopolitica mondiale: senza un’unità politica, economica e militare, il modello sociale europeo verrà schiacciato da altri, oggi assai più competitivi; mentre tutto ciò che siamo, ciò in cui crediamo, diventerà il ricordo di un mondo di ieri.