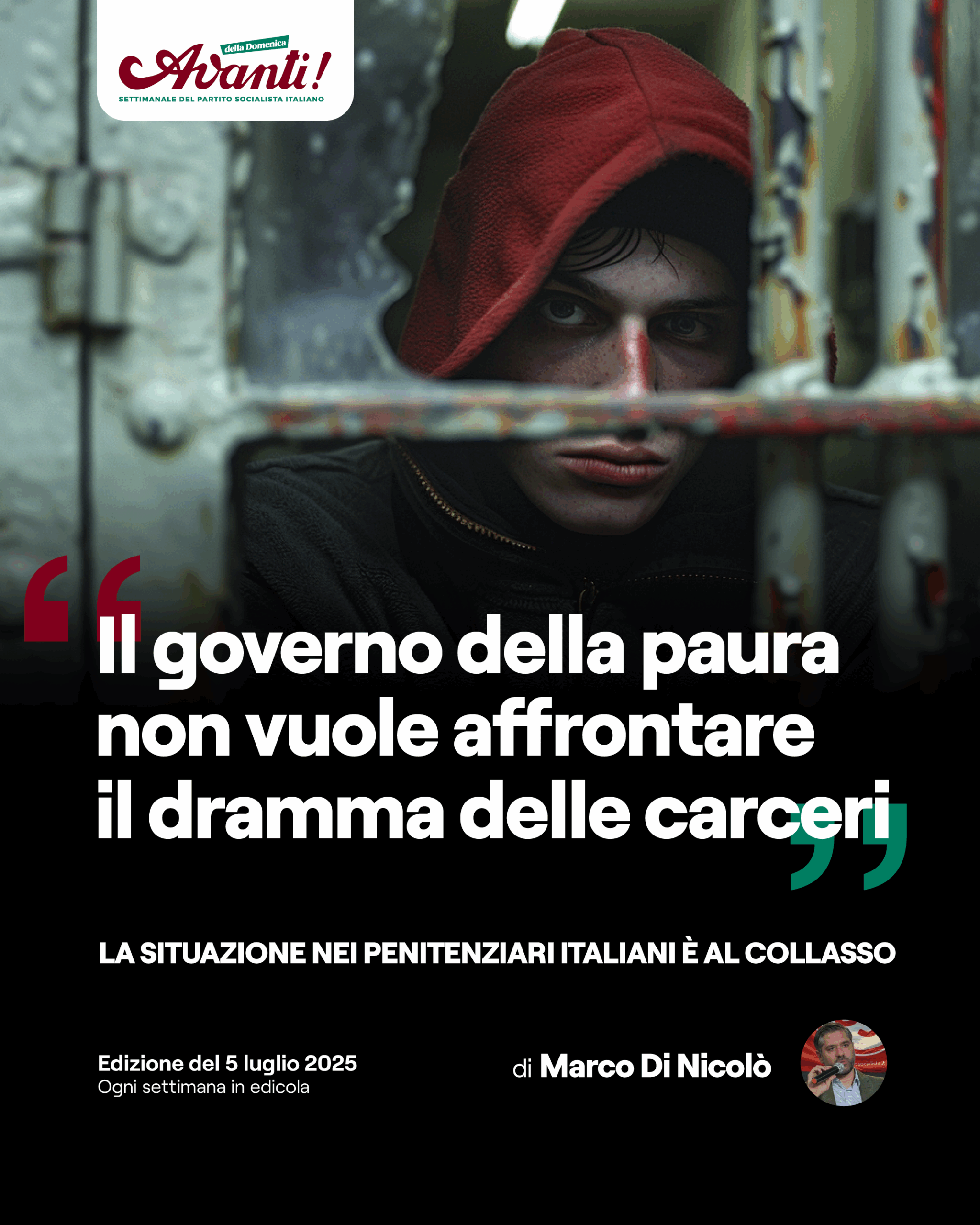di Marco Di Nicolò
Un paio di mesi fa il Ministro della Giustizia Nordio ha dichiarato che il sovraffollamento carcerario dipende dai giudici che imprigionano troppo e non dalle leggi approvate dal governo Meloni. Questa affermazione rivela quanto il populismo penale condizioni il dibattito pubblico e quanto poco contribuisca a risolvere i problemi reali: né in termini di sicurezza né in termini di rispetto dei diritti fondamentali. Il diritto penale viene impiegato come strumento di propaganda. Alimentare la paura, proporre soluzioni semplicistiche e punitive, serve solo a costruire consenso, non Giustizia. Il governo Meloni ha fatto proprio questo meccanismo, già ampiamente consolidato nel passato. Lo schema è semplice. In primis, si conquista il consenso di massa tramite politiche securitarie. La percezione dell’insicurezza è una costruzione sociale fondamentale per giustificare l’approvazione di misure illiberali. La realtà del Paese è ben diversa: l’Italia è uno dei Paesi più sicuri dell’Unione europea. I dati raccolti dal Ministero dell’Interno sono chiarissimi. Poi si utilizza il tendenziale colpevolismo dell’opinione pubblica. Le garanzie non fanno parte della cultura di massa e gli indagati/imputati non si presumono innocenti, ma colpevoli, spettacolarizzando il processo penale. In ultimo, considerata la crisi di identità politica che ristagna dentro a contenitori politici informi, si intercetta la necessità dell’elettorato di definirsi sulla base dei propri nemici, spesso del tutto immaginari. Tutti i populismi hanno bisogno di legittimarsi attraverso un nemico o, meglio, attraverso più nemici. L’odio funge da aggregatore politico. Contestualmente il tasso di sovraffollamento nelle carceri è aumentato dal 109% nel 2022 al 133% nel 2025: si è passati da 56.196 detenuti a 62.445. Un incremento che non è giustificato dall’andamento dei reati, rimasti stabili nel triennio. A risultare maggiormente colpiti sono stati i migranti e i minori. I minori detenuti sono aumentati del 60% in soli diciotto mesi dall’approvazione del Decreto Caivano. Gli ingressi negli istituti penitenziari minorili hanno coinvolto soprattutto ragazzi stranieri non accompagnati. Anche i migranti irregolari in carcere sono aumentati, dopo l’approvazione della legge 50/2023 (decreto Cutro). Queste norme, insieme al pacchetto sicurezza del 2025 e alla legge sull’autonomia differenziata, hanno prodotto un impatto diretto e indiretto sulla popolazione carceraria: da un lato inasprendo pene e limitando le alternative alla detenzione, dall’altro riducendo le risorse per percorsi di reinserimento extra-carcerari. È ormai certo che la sicurezza e la giustizia sociale non si perseguono con il carcere e con la repressione. I dati dicono esattamente il contrario: le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare) determinano un tasso di recidiva inferiore al 20%, contro un tasso di recidiva che supera il 68% per chi sconta la pena in carcere. Purtroppo vi è di più. Il circuito della detenzione in carcere e il sistema dell’esecuzione penale esterna si configurano come sistemi indipendenti l’uno dall’altro e, di fatto, riguardano tipologie e caratteristiche di persone diverse tra loro. Secondo il Rapporto Antigone 2024 e dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la grande maggioranza dei detenuti proviene da contesti di marginalità sociale ed economica. Circa il 75% non ha un impiego stabile al momento dell’arresto. Molti non hanno una residenza fissa e dipendono dall’assistenza pubblica o familiare. Il Garante nazionale dei detenuti stima che oltre il 40% dei detenuti presenti disturbi psichiatrici, spesso non diagnosticati o mal gestiti. Le persone transgender subiscono una doppia vulnerabilità: vengono frequentemente inserite in istituti non conformi alla loro identità di genere e subiscono più episodi di isolamento, discriminazione e violenza. Le linee guida del Dap prevedono tutela, ma non sono uniformemente applicate. Le persone che accedono alle misure alternative alla detenzione hanno un profilo diverso in termini di integrazione sociale e di stabilità economica. Del resto, il populismo penale si nutre della spettacolarizzazione del processo, del sospetto verso le garanzie, dell’illusione punitiva. Facciamo alcuni esempi: il nuovo art. 633-bis c.p., introdotto con la legge 199/2022 (“anti-rave”) approvata a seguito di una serie di eventi di cronaca, ha prodotto molti fermi preventivi nei primi dodici mesi e pochissime condanne. La legge n. 50/2023, approvata dopo la tragedia di Cutro ove persero la vita novanta migranti, ha aumentato inutilmente le pene, già decisamente alte, per favoreggiamento dell’immigrazione e posto nuovi ostacoli alla protezione speciale. Tale misura ha determinato un considerevole aumento degli stranieri e migranti in carcere soprattutto per i reati minori e meno gravi. Infine, ci sarebbero la Legge 80/2025 (conversione DL 48/2025 “Pacchetto Sicurezza”) e la legge 86 del 26 giugno 2024 sull’autonomia differenziata. La prima misura introduce quattordici nuovi reati (resistenza passiva, blocchi stradali, occupazioni), esclude le misure alternative alla detenzione per molte fattispecie e irrigidisce l’ordinamento penitenziario, colpendo ancora una volta le persone più fragili. Rispetto a questa deriva illiberale, esistono ancora anticorpi democratici? Si, sono la cultura delle garanzie, l’identità politica non subalterna all’emotività, la competenza e i principi sanciti dalla nostra Costituzione.