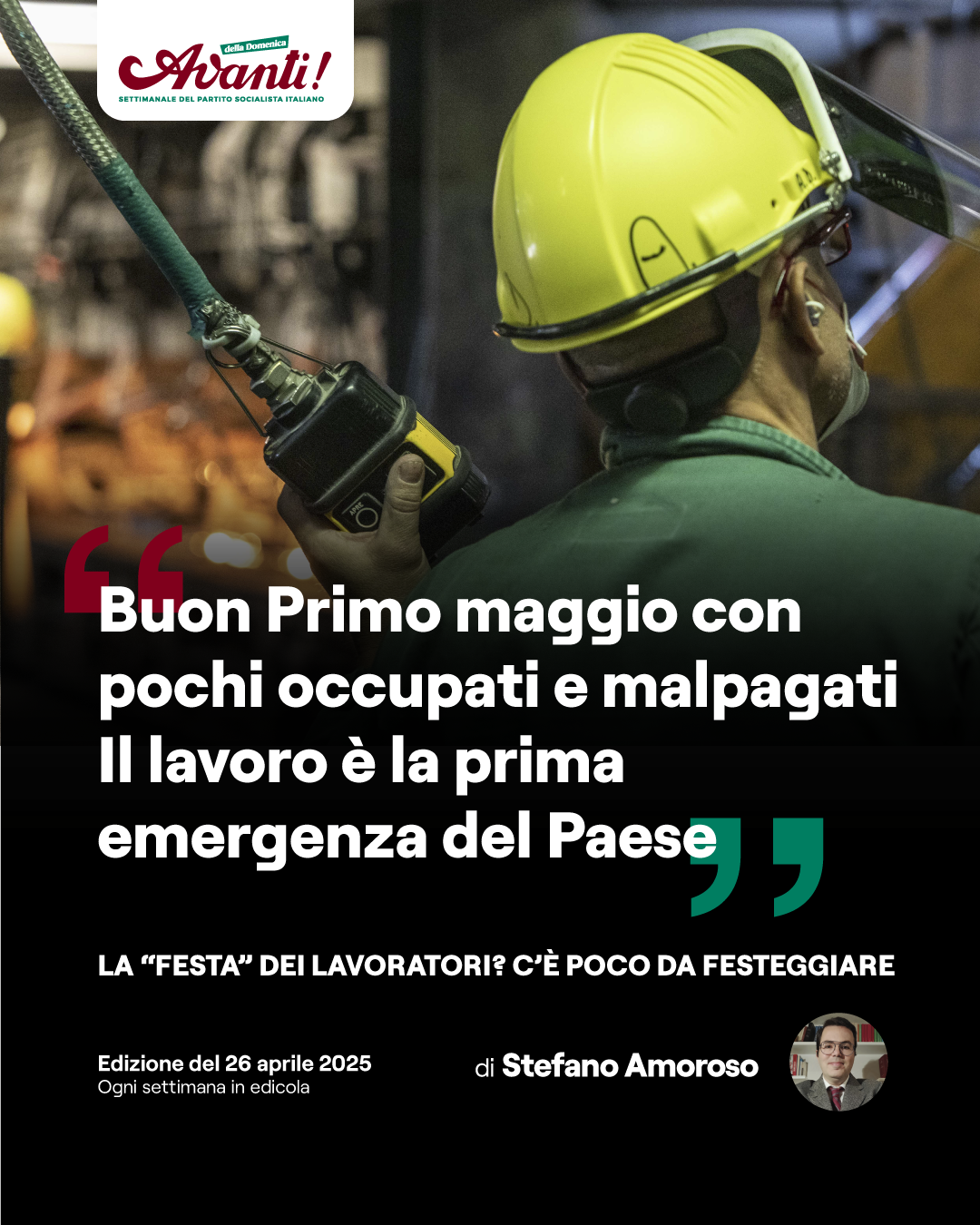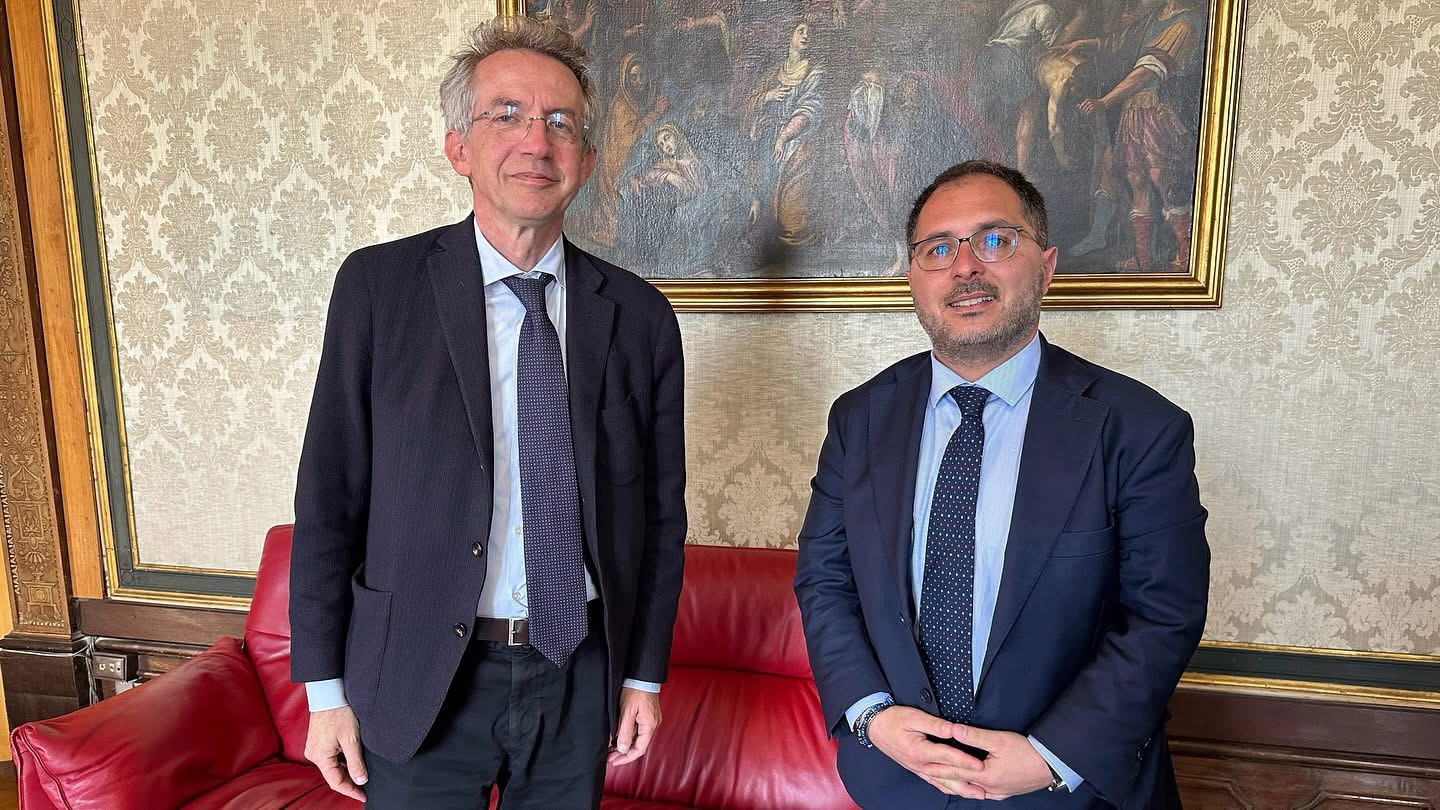di Stefano Amoroso
Ha suscitato scalpore, subito prima di Pasqua, la pubblicazione della classifica delle regioni dell’Unione Europea in base al tasso di occupazione: tre delle ultime quattro sono italiane. Si tratta di Campania, Sicilia e Calabria, in ordine crescente, appena al di sopra della Guyana francese nella classifica degli occupati in rapporto al totale della popolazione. Il pessimo risultato di tre delle quattro regioni più popolose del Sud è dovuto a vari fattori, come l’elevata disoccupazione giovanile (tendenzialmente i giovani trovano lavoro più difficilmente, per cui un territorio con un ampio numero di giovani può avere, per motivi fisiologici, un livello di occupazione più basso), la scarsa industrializzazione e livello infrastrutturale, il basso livello di istruzione ed il limitato accesso a servizi pubblici ed opportunità lavorative. Nel caso delle Regioni del Sud Italia, senza nessuna eccezione, sono proprio questi ultimi tre fattori a pesare negativamente sul livello e la qualità dell’occupazione. Spesso, poi, gli elementi sfavorevoli si sommano e potenziano tra di loro, creando una tendenza al sottosviluppo assai difficile da invertire. Così, ad esempio, la storica e drammatica carenza d’infrastrutture che colpisce molte zone interne e montuose del nostro Sud rende difficile accedere a servizi pubblici e ad opportunità d’istruzione extrascolastica che possano fare la differenza: così, limitati alla sola mediocre istruzione pubblica fornita dallo Stato gli studenti ed i lavoratori che si vogliano riqualificare, in tante zone del Sud, accumulano ritardi nelle competenze chiave del mondo moderno, come quelle digitali, e di conseguenza sono condannati a competere con i migranti per i lavori meno qualificati e peggio pagati, come quello del rider. Non è che il resto del Paese sia messo molto meglio: nel Centro Nord, ad esempio, infrastrutture e diffusione dei servizi pubblici sono generalmente di buon livello, ma la scarsa natalità che ci trasciniamo dietro da decenni, fa sì che ormai manchino intere classi demografiche e che metropoli come Milano siano interamente dipendenti dalle migrazioni, sia interne che dall’estero, per far funzionare diversi servizi. Il risultato amaro è che il livello medio di occupazione del Paese, pur avendo raggiunto il livello massimo (66%) da quando esistono le serie storiche nella UE, resta decisamente al di sotto della media europea del 75,3% e rende molto problematico raggiungere il livello prefissato del 78% per la fascia d’età 20- 64 anni entro il 2030. L’unico territorio italiano che supera la media europea è, attualmente, la Provincia Autonoma di Bolzano (79,6%) ma anche in quel caso siamo ben al di sotto dei primi della classe nella UE: Paesi Bassi (84%), Svezia (83%) ed Estonia (82%). Pochi occupati, dunque, e pure mal pagati: un’altra ricerca europea, di cui abbiamo già parlato su queste pagine, ha dimostrato che il potere d’acquisto dei salari italiani, caso unico nell’Unione, è calato di quasi il 3% nella serie storica dal 1990 al 2022. Nello stesso periodo, invece, il potere d’acquisto del salario medio polacco è cresciuto del 65%, quello lituano del 64% e quello rumeno del 52%. Probabilmente lo sviluppo maggiore della contrattazione di secondo livello, più vicina alle esigenze dei lavoratori e delle imprese (prevalentemente PMI) che li impiegano, ed orari più flessibili per conciliare esigenze lavorative, familiari ed acquisizione di competenze, potrebbero aiutare a far aumentare sia il numero degli occupati che le loro competenze e, di conseguenza, la loro produttività. Ci vorrebbe, inoltre, un maggiore incentivo ad effettuare investimenti produttivi, in primis quelli in ricerca e sviluppo, che sono fondamentali per la crescita della competitività delle imprese. Tanto per fare un esempio, ancora oggi l’applicazione delle norme sulle detrazioni e deduzioni dalle imposte degli investimenti in startup e PMI innovative, introdotte da Monti nel 2012, risulta difficile e non privo di ostacoli. Anche perché sono ben pochi i funzionari dell’Agenzia delle Entrate che sono stati formati in tal senso. Di conseguenza, mentre lo Stato deve fare i conti con la revisione della spesa ed i vincoli dei Trattati Europei, teniamo sequestrato l’enorme risparmio privato delle famiglie italiane, che viene perciò dirottato prevalentemente sull’acquisto di buoni del Tesoro e sul mercato immobiliare, aumentandone le quotazioni in maniera artificiale, con la conseguenza che ad oggi l’acquisto di una casa per una giovane coppia di lavoratori è un miraggio. Quindi lo Stato italiano emette debito per assistere giovani e famiglie povere, e si fa finanziare questo debito dai nonni. Invece potrebbe incentivare l’investimento dei nonni sulle competenze dei nipoti, più digitali e fresche delle generazioni passate, e con ciò genererebbe sviluppo, crescita ed aumento dei salari. Invece delle canne da pesca e della formazione per pescare, continuiamo a distribuire pesci per sfamare una parte della popolazione che non mettiamo in condizione di esprimere il suo potenziale.