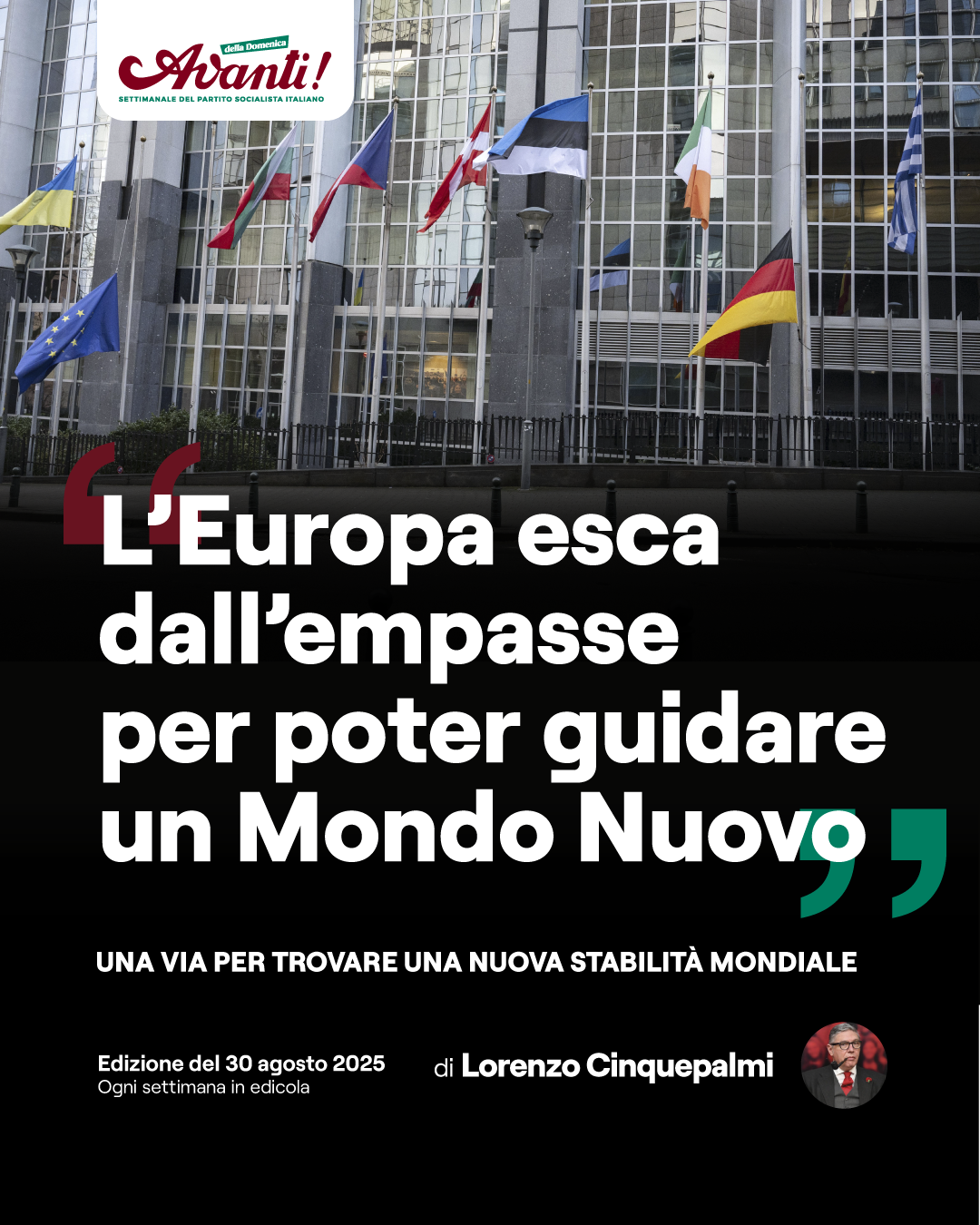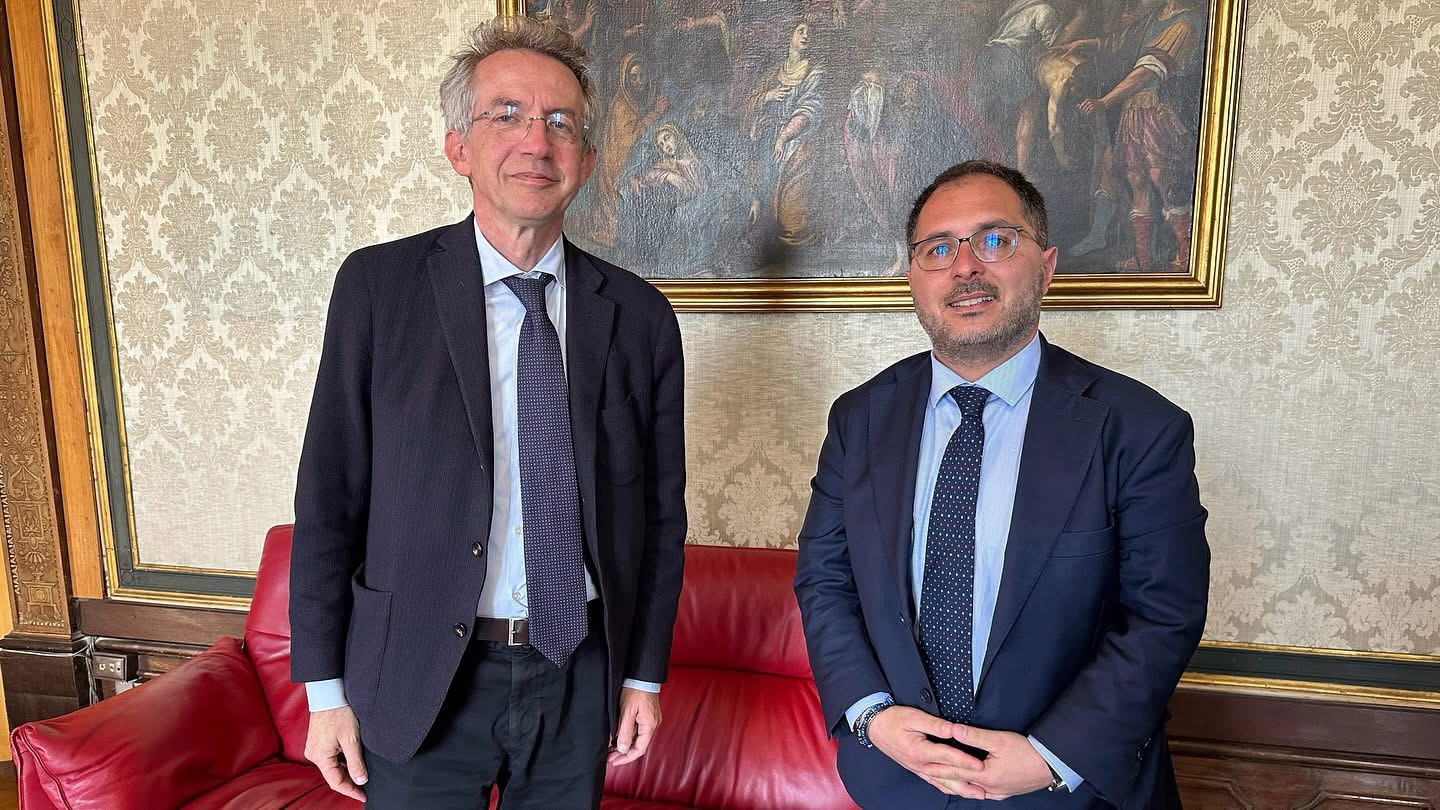di Lorenzo Cinquepalmi
L’espressione “Nuovo Mondo” per secoli ha identificato, tradizionalmente, le Americhe. Oggi, l’involuzione anti progressiva imposta da Trump, ha fatto perdere alle Americhe ogni attitudine al nuovo e quel testimone giace abbandonato in attesa di essere raccolto, dopo che il continente che per primo ha liberato i suoi popoli dal giogo coloniale europeo, facendo della libertà, pur attraverso molteplici contraddizioni e contrasti, la sua vera bandiera, della stessa ha rotto il tabù in modo irreversibile. Questo ha valorizzato e sta valorizzando tutte le peggiori spinte reazionarie e imperialiste del pianeta. L’inusitata convergenza di interessi tra Trump e Putin ha tolto la Russia dal pur debole isolamento seguito alla sua aggressione militare dell’Ucraina. Netanyahu si sente libero di fare cose che nel mondo di ieri non avrebbe azzardato e che non sarebbero state tollerate dalla comunità internazionale. La Cina, un altro potenziale mondo nuovo che, però, tale non può essere per la mancanza dell’essenziale ingrediente della libertà, conquista ogni giorno nuove frontiere con il suo neocolonialismo economico, preparando nel contempo uno strumento militare sempre più poderoso e pronto a consolidare con le armi le conquiste coloniali, magari imitando la Russia e rivolgendole contro la provincia ribelle di Taiwan. Così, nel processo imitativo che talvolta concorre a creare i mainstream della storia, anche le medie potenze cresciute negli ultimi decenni, sempre in bilico tra libertà democratiche e aggressività autoritaria, inclinano pericolosamente verso quest’ultima, creando le condizioni per una perniciosa instabilità mondiale in cui, perduti equilibri e regole nati nel secondo dopoguerra, leader politici spregiudicati provano a cogliere qualsiasi occasione. Alla fine del secolare giro di giostra della storia, il testimone di un Nuovo Mondo può e deve essere raccolto proprio dal Vecchio Mondo, dall’Europa. Si badi, non l’Unione Europea, istituzione vecchia, logora e paralizzata da una costituzione figlia degli originari egoismi di quegli stati nazionali che, scrivendola, pensavano ai loro interessi particolari e non al sogno di Ventotene raccolto da Adenauer, Schumann e De Gasperi. Una nuova Europa, dunque, promossa dai suoi stati guida, Francia e Germania, alla cui iniziativa non potrà non aderire l’Inghilterra. La forza gravitazionale di questo nucleo forte, di cui l’Italia sarebbe componente naturale se non fosse così mal governata da una maggioranza refrattaria a quei valori, attirerà facilmente la Spagna, inevitabilmente la Polonia, e infine, benché riottosamente, anche l’Italia stessa, così legando tra loro le nazioni che costituiscono la larga maggioranza economica, demografica e territoriale europea, in un trattato che sia fondato su quegli strumenti che l’Unione non ha mai saputo darsi: una difesa comune, una politica economica e fiscale comune, l’abbandono della zavorra costituita all’unanimità delle decisioni. Solo una spallata di questa portata può resuscitare l’ideale dei fondatori, azzoppato dal vanaglorioso nazionalismo di De Gaulle, con l’affossamento della difesa comune, nel lontano 1954. Su questi temi è intervenuto, di recente e in modo convincente, Mario Draghi, la cui analisi della situazione europea nel contesto geopolitico mondiale, esposta nell’intervento tenuto a Rimini lo scorso 22 agosto, ha diversi punti di contatto con quanto fin qui descritto. Nel trarre le conseguenze della sua analisi egli si mantiene più prudente, restando ben lontano dal formulare una proposta politica. Esorta a realizzare più ampie forme di integrazione economica, sottolineando il costo, in termini di perdita di competitività, dei residui di protezionismo nazionale ancora esistenti ma, pur denunciando la lentezza, l’immobilismo, l’inazione dell’entità politica europea, non propone una soluzione. È tuttavia ben chiaro come il processo decisionale dell’Unione sia impossibile da riformare in modo non traumatico, proprio perché il vincolo dell’unanimità permette a modesti leader nazionali di inseguire un personale consenso, loro e delle loro forze politiche, al prezzo della negazione del progresso del loro stesso popolo, oltreché dell’intera società europea. Un esempio per tutti, l’ungherese Orban. Draghi, nel constatare che il sistema degli equilibri e delle regole di fine ‘900 è irrimediabilmente venuto meno con il ritorno della legge del più forte, e nel dire che l’Europa, così com’è, è già marginale e condannata a una marginalità sempre maggiore, con conseguente e inarrestabile perdita di benessere per gli europei, delinea lo scenario in cui non vi è alternativa al declino se non nella fondazione di un’istituzione politica europea in possesso delle prerogative di sovranità oggi ancora frazionate nei singoli stati membri. Ciò che pare inevitabile aggiungere, come s’è detto, è l’impossibilità di credere che la combinazione perversa tra un meccanismo decisionale fondato sull’unanimità e la mancanza di leadership adeguate alla congiuntura storica, permetta di riformare l’Unione facendola evolvere verso una massiccia cessione di sovranità dagli Stati, presupposto indefettibile per la conquista dell’autorevolezza, dell’autorità, della forza e della rapidità di decisione indispensabili per un confronto possibile con le attuali potenze mondiali in un sistema di bellum omnium erga omnes. L’illusione di smentire Hobbes è morta; è ora di accettarne la teoria all’esterno per superarla all’interno, se vogliamo cercare di tenere in vita il modello sociale europeo.