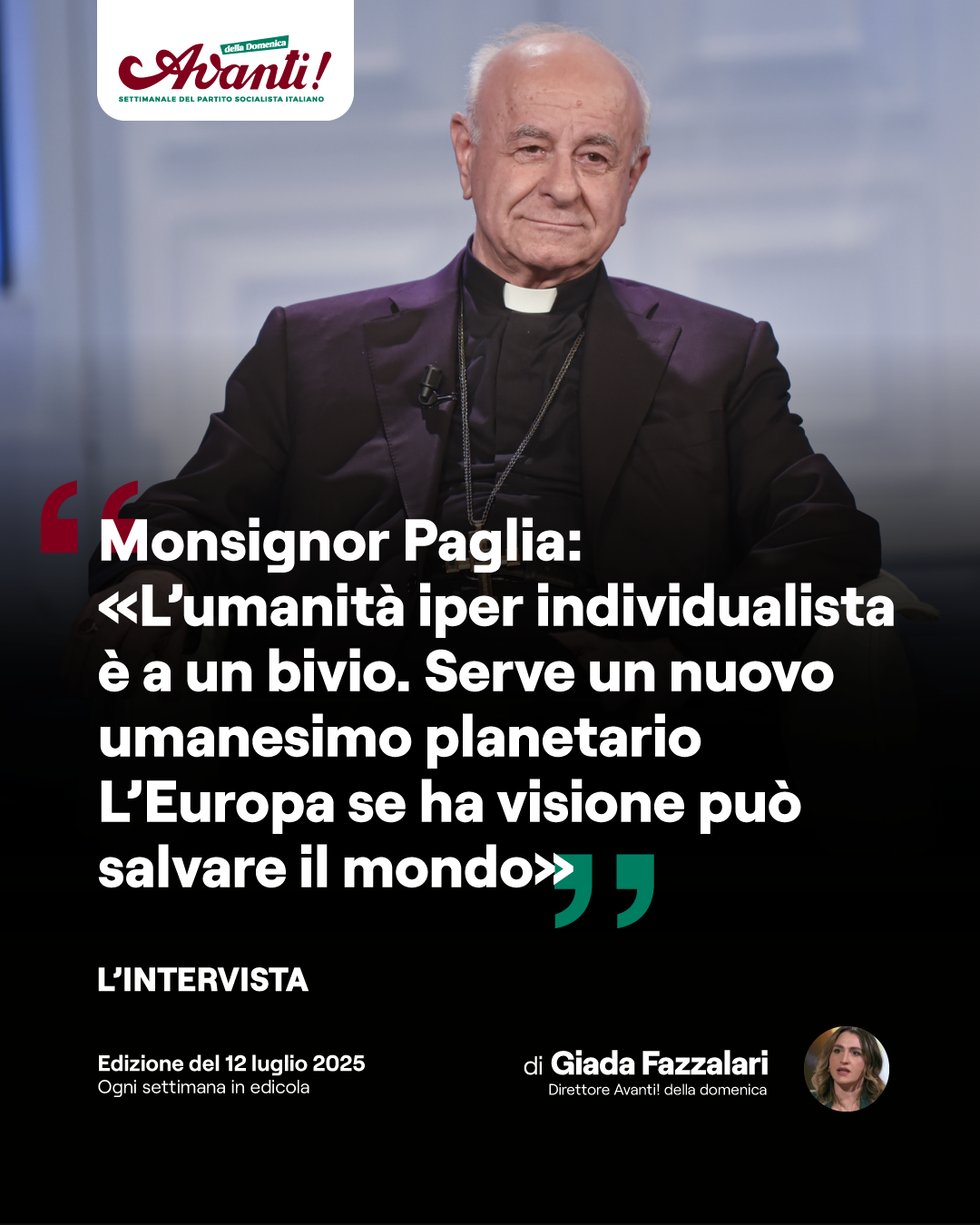di Giada Fazzalari
In un mondo che sembra aver ribaltato il suo sistema di valori e che è cambiato radicalmente, animato da conflitti e fratture sociali, l’umanità si trova in nuovo tornante della storia che la pone di fronte a un bivio: o si disgrega di fronte all’iper-individualismo che l’ha caratterizzata negli ultimi decenni, oppure dovrà riscoprire un nuovo umanesimo planetario, un avvertimento lanciato dallo stesso Papa Francesco, rimasto inascoltato. È questo il cuore del dialogo con Monsignor Vincenzo Paglia, che con Papa Bergoglio ha condiviso da vicino un lungo tratto di vita durante il suo pontificato, oggi uno dei grandi riferimenti pensiero cattolico italiano, acuto e attento osservatore delle dinamiche sociali che caratterizzano il nostro tempo. Già Presidente della Pontifica accademia per la vita, consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, Monsignor Paglia ha pubblicato, per Edizioni San Paolo, “Destinati alla vita” sul tema della vecchiaia e del fine vita. Temi che lo hanno da sempre visto protagonista, anche con attacchi mossi dall’ala più conservatrice della Chiesa. Monsignor Paglia lancia una suggestione: se l’Europa recupererà lo spirito unitario dei padri fondatori, del ‘noi’ e non dell’’io’, con un sussulto visionario, ambizioso ed audace, allora potrà salvare il mondo. Un principio che tutti, dalla politica, ai corpi intermedi, ai tanti segmenti della società, dovrebbero utilizzare come bussola per il futuro. Riflessioni che costituiscono una preziosa mappa per orientarsi nel caos del presente.
Monsignor Paglia, viviamo in un tempo segnato da tensioni internazionali, fratture sociali, l’emergere di nuove autarchie. Lei ha recentemente detto che è in corso “un cambiamento d’epoca, il cui esito può essere anche la fine del mondo di come lo conosciamo noi”. È preoccupato?
«La situazione è preoccupante già ad uno sguardo superficiale: guerre che si moltiplicano e non terminano, disastri ambientali che provocano anche vittime, crisi delle democrazie. Tutto questo si iscrive in un reale cambiamento d’epoca che pone l’umanità di fronte ad un bivio: o continuiamo a disgregarci mutando la stessa condizione umana oppure dobbiamo favorire la nascita e lo sviluppo di un nuovo umanesimo planetario. Credo sia arrivato il momento che l’avvertimento che già faceva Papa Francesco, purtroppo inascoltato, venga preso sul serio da parte degli spiriti più attenti a tutti livelli della società. È indispensabile un sussulto di pensiero, di etica e di visione».
Il nuovo umanesimo cui lei fa riferimento sembra richiamare a quelle società di mutuo soccorso che nel secolo scorso combinavano elementi di solidarietà socialista con principi cristiani per affrontare le fragilità sociali dell’epoca.
«La storia dovrebbe essere magistra vitae. Purtroppo spesso non lo è. Poniamo attenzione all’attualità. Ci troviamo nel mezzo di un’epoca infettata da un individualismo crescente che, come un malefico e terribile virus, sta sgretolando il senso della socialità, del bene comune, del destino comune; insomma, dell’essere assieme. Gilles Lipovetsky, un filosofo francese contemporaneo, parla di una seconda rivoluzione iper-individualista: l’io ha preso il sopravvento su tutto. Si può parlare di una vera e propria dittatura dell’individuo. Giuseppe De Rita parla della nascita di una nuova religione, la “egolatria”, il culto dell’io sul cui altare si sacrifica tutto, anche gli affetti più cari; basti pensare ai femminicidi, e tanto altro, ovviamente».
Come si deve reagire, per non rimanere ‘incastrati’ in questa dimensione sociale iper individualista che rende tutti un po’ più soli?
«Di fronte a questa nuova “religione” – e direi che siamo tutti rigorosamente monoteisti: non avrai altro dio all’infuori di me – è urgente riscoprire il “noi”. Si tratta di ritessere relazioni umane tra noi come il cardine della vita sociale. Possono ispirarci le prime pagine della Bibbia, quando Dio stesso disse “non è bene che l’uomo sia solo”, e creò anche la donna. Ad ambedue, alla loro alleanza, affidò la custodia del giardino e la cura delle generazioni. L’uomo è fatto di relazioni. L’individuo assoluto (absolutus, ossia sciolto da tutto) non è mai esistito. Nessuno è auto-nato, come l’ombelico ci ricorda».
Come Paese, ma anche come istituzioni europee, saremo capaci di preservare il nostro sistema di valori? Può tornare ad essere la nostra Europa uno spazio di convivenza pacifica, di giustizia sociale, come era quando è stata fondata?
«Io temo che purtroppo il sogno che ebbero nell’immediato secondo dopoguerra, quei tre giganti che erano De Gasperi, Adenauer e Schuman, dopo i primi passi molto positivi, si è come arenato. Ci troviamo di fronte ad un’Europa incompiuta. C’è il mercato comune, c’è la moneta comune, manca per il resto, ad esempio, la difesa comune, una politica estera comune…e soprattutto una unione politica sul piano federale. Se questo non avviene l’Europa rischia non solo l’irrilevanza ma anche di arretrare. Resta ancora una costruzione straordinaria, ma deve andare oltre. Abbiamo bisogno di più Europa, non di meno. Ci troviamo di fronte ad un bivio».
Quale?
«Un’Europa rimane incompiuta, rischia di fare passi indietro – basti pensare ai rischi dei sovranismi o alle cosiddette democrature che stanno rendendo fragilissima la coalizione dei 27 Paesi – un’Europa più audace diventa una realtà positivamente competitiva nel contesto internazionale sia sul piano della politica che dell’economia e della stessa dimensione istituzionale. Se intraprende la seconda via l’Europa diventa un pilastro indispensabile per un mondo più unito».
L’Europa però sembra priva di slanci emotivi. Era nata con l’idea di essere un’Europa politica ma quel passo non è mai stato fatto. Con quali strumenti l’Europa si può difendere dalle minacce di nuove democrature che la rendono più fragile?
«Dovremmo recuperare quello spirito che spinse i fondatori dell’Europa ad avere uno slancio del ‘noi’ a discapito dell’‘io’. C’è bisogno di uno scatto di visione, di un sussulto di orgoglio del ‘noi’ europeo. Se questo avviene, l’Europa davvero può salvare il mondo dalla tristissima condizione nel quale è caduto».
Perché?
«Perché quel patrimonio di forza mite, di umanesimo universale, di cultura dei diritti, non solo individuali ma anche sociali e che hanno fondato l’universalità, oggi hanno bisogno di una rivitalizzazione perché determinino le prospettive anche degli altri Continenti. Penso alla Cina, agli Stati Uniti, al Sud del mondo. Tutti hanno beneficiato nei secoli passati di un’Europa universalista ed umanista. Oggi l’indebolimento delle istituzioni internazionali è una delle conseguenze dell’indebolimento della cultura europea. Ecco perché ritengo indispensabile non una semplice riorganizzazione dell’Europa, ma un vero sussulto umanistico. Dobbiamo auspicare un’Europa che non si chiuda in sé stessa ma che abbia l’audacia di pensare in grande come ha fatto in passato».
In Italia crescono le diseguaglianze sociali, l’Istat e la Caritas ci dicono che ci sono 5,7 milioni di persone che vivono nella povertà, a rischio e esclusione sociale. I partiti e la politica cosa dovrebbero fare per essere all’altezza di una società che combatta le diseguaglianze sociali?
«La politica dovrebbe riscoprire sé stessa, quella con la “P” maiuscola. Quando parlo di politica intendo certamente i partiti – che debbono ripensarsi, anche perché sono diventati per lo più coalizioni “personali” – ma anche le altre articolazioni della società, dai sindacati alle organizzazioni sociali, dalle aggregazioni economiche a quelle religiose, e così oltre. Immagino una società poliarchica, ossia una società dove i corpi intermedi e tutti gli altri, sentano la responsabilità di edificare una società plurale, della quale ciascuna parte deve sentirsi responsabile. Ma questo richiede non solo un cambio di passo, ma anche una visione del destino comune che commuova e appassioni. Fa pensare la definizione degli italiani data dal rapporto Censis dello scorso anno: sonnambuli. La foto è quella di una folla di individui, non di un popolo o anche di più popoli che cercano comunque la destinazione comune. In questo senso serve un sussulto da parte di tutta la società, nelle sue diverse articolazioni: insieme si può sognare un’Italia comune che rispetta le diversità, ma dove nessuno è escluso, dove le ingiustizie sono combattute, le disuguaglianze annullate. Un accoglimento più attento dell’insegnamento di Papa Francesco con le due grandi encicliche, Laudato sì e Fratelli tutti, potrebbe aiutarci. I due testi citati delineano la visione di cui non solo l’Italia ma tutti i Paesi hanno bisogno: abbiamo una sola casa comune, il pianeta, e tutti hanno diritto di abitarla, tutti hanno il dovere di custodirla. Abbiamo perciò una casa comune (il pianeta), abitata da un’unica famiglia plurale (i popoli) e un’unica mensa che non esclude nessuno. È la visione di cui l’intera umanità ha bisogno».
È questo l’umanismo planetario a cui accennava prima?
«Proprio così. In quest’unica casa, quest’unica famiglia, ha un’unica mensa dalla quale nessuno deve essere escluso. È la visione di cui l’Italia ha bisogno. Anzi, tutti i popoli ne hanno bisogno. È quell’umanesimo che promuove una effettiva fraternità con il creato e tra i popoli. È il mondo di cui abbiamo bisogno se vogliamo allontanare le guerre, togliere in radice le disuguaglianze e permettere uno sviluppo sostenibile ove tutti vivono in pace rispettando le diversità».
Il progetto avviato da Papa Francesco era anche quello di una Chiesa più aperta ed inclusiva…
«Papa Francesco voleva una Chiesa in uscita verso gli altri. E si adoperava perché anche le altre religioni seguissero la stessa strada. La Chiesa cristiana in particolare, per la sua ispirazione evangelica, è chiamata non a servire sé stessa ma a servire la fraternità dei popoli. La Chiesa deve essere fermento che lievita l’intera pasta in maniera fraterna ed anche sale che deve rendere saporoso l’intero. Oggi la Chiesa (e i cristiani) devono sentirsi responsabili della vita degli otto miliardi di cittadini del mondo, come anche della cura del pianeta che è la casa comune di tutti. Questa è la missione che Dio ha affidato alla Chiesa e che oggi deve essere riscoperta».
E che ruolo possono ancora giocare i cattolici cristiani come impegno politico?
«Il fatto che l’astensionismo al voto sia così alto indica una irresponsabilità di coloro che si astengono. I cattolici devono essere preoccupati per questo, proprio perché essi per primi sono chiamati ad assumersi le responsabili per la Politica (con la lettera maiuscola), che comporta anche l’impegno della politica dei partiti e delle altre organizzazioni sociali. Certo, non si risolve l’impegno verso la società con la sola adesione ai partiti. Essi, tuttavia, sono oggi una parte importante della vita politica. Ed ecco perché c’è bisogno che i cattolici sentano la responsabilità di partecipare alla vita politica. I cattolici non possono restare chiusi nelle Chiese (debbono cioè non restare bloccati in una sterile ed anche triste autoreferenzialità). Insomma, tra la Chiesa e la piazza non dovrebbero esserci più gradini».