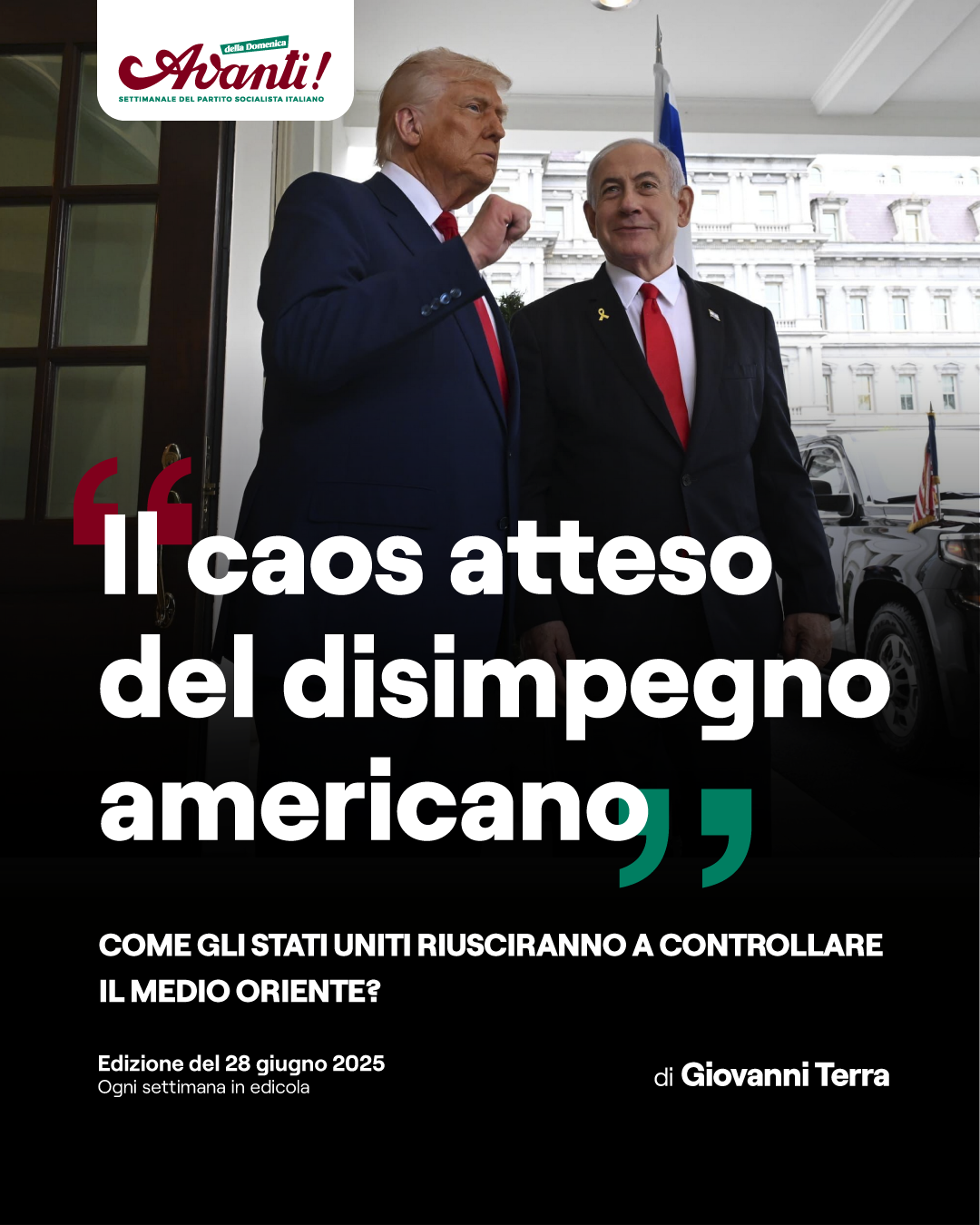di Giovanni Terra
L’attuale postura americana va interpretata considerando che lo scenario è quello di concentrare le proprie risorse contro la Cina e che si traduce in un progressivo ricollocamento verso il Sud-Est asiatico, accompagnato da un disimpegno — politico, militare, economico — nelle altre aree. Sul piano della sicurezza è bene chiarire che gli Stati Uniti non intendono rinunciare al proprio ruolo egemonico, come talvolta si suggerisce soprattutto in Europa. Al contrario, puntano a un controllo più agile e indiretto, prevedendo deleghe di responsabilità ai partner regionali in Europa, Levante e Africa. Sul piano economico la strategia mira a rafforzare la capacità industriale e manifatturiera interna, anche a costo di indebolire i legami commerciali tradizionali con gli alleati. Tuttavia, questa visione presenta delle discontinuità logico-politiche e debolezze strutturali, tali da compromettere il contenimento della Cina o di arrivarci per una sorta di eterogenesi dei fini, ovvero attraverso effetti non intenzionali e potenzialmente destabilizzanti. Il primo punto critico è l’assenza, nella strategia americana, di un reale sforzo per la risoluzione o la pacificazione dei conflitti. Si assiste piuttosto a una gestione tattica, episodica, priva di un orizzonte negoziale o di processi multilaterali di pace. L’obiettivo sembra essere la mera modulazione dell’intensità dei conflitti, con fasi di congelamento temporaneo. Il secondo elemento riguarda la percezione internazionale. Oggi, molti attori leggono l’azione americana come un “abbandono”. Questa sensazione trova fondamento nell’uscita dall’Afghanistan, pianificata da Trump e lasciata in eredità a Biden. Un evento che ha simbolicamente segnato la fine dell’idea degli Stati Uniti come “poliziotto globale”. Il terzo elemento è rappresentato dalla rinuncia pubblicamente dichiarata al proprio passato interventista, accompagnata dalla promessa — rivelatasi elettoralmente efficace — di astenersi da interventi militari diretti nel mondo. Una scelta che ha incentivato ambiziosi attori internazionali a correre rischi maggiori. Questi fattori rappresentano sfide potenzialmente dirompenti per l’efficacia della nuova strategia americana. Da un lato, offrono agli attori regionali ambiziosi la sensazione di avere mano libera; dall’altro, forniscono loro una giustificazione ideologica per riaprire conflitti mai realmente risolti. Nel contesto di questo riequilibrio strategico, qual è il posto del Medio Oriente? La visione statunitense prevede una sorta di contenimento degli attori regionali — medie e piccole potenze — entro un sistema di equilibri che impedisca l’emersione egemonica di uno solo. Una linea rossa invalicabile rimane la sopravvivenza dello Stato di Israele. Tuttavia, il Levante resta una delle aree più fragili e instabili del pianeta: conflitti cronici, confini labili, entità statuali deboli o fittizie, e attori regionali estremamente ambiziosi. In questo quadro, la riduzione della presenza americana rischia di avere un effetto moltiplicatore sull’instabilità, favorendo un’escalation di crisi regionali in grado, a loro volta, di costringere gli Stati Uniti a rientrare nel teatro, smentendo nei fatti l’ipotesi del disimpegno. Il futuro dell’Iran, per quanto oggi incerto, continua ad essere un nodo strategico. Sotto un decennale embargo, fino a poco tempo fa esercitava un’influenza dalla sua frontiera occidentale fino al mare. Israele, dopo anni di conflitti logoranti, ha raggiunto un successo politico importante e confina con stati falliti o instabili. Uno scenario che potrebbe continuare giustificare la logica aggressiva e magari anche giustificare l’annessione della Cisgiordania, del sud del Libano e parti della Siria, dando corpo all’ideale della “Grande Israele”. Tuttavia, gli effetti di lungo periodo del “vivere di spada” lacerano lo stesso Stato ebraico, sempre più pieno di milizie e con una popolazione polarizzata e abituata alla violenza. L’Arabia Saudita è l’attore che ha perso più terreno: uscita sconfitta dalla guerra in Yemen, ha dovuto rinunciare a ogni ambizione egemonica, come dimostrato anche dal fallimento del blocco diplomatico contro il Qatar. Per questo oggi ha intrapreso un progetto di modernizzazione culturale, sociale ed economica che rappresenta una sfida esistenziale. Specialmente se l’Egitto, il cui equilibrio finanziario dipende dai sauditi, dovesse precipitare nuovamente nel caos. Il Cairo è un esercito-Stato che confina con Libia e Sudan in guerra civile e mantiene forti tensioni con l’Etiopia. La Siria, se non torna Stato, rischia lo smembramento definitivo. L’ipotesi che tra dieci anni la Turchia (braccio armato del Qatar) possa annettersi i territori a Nord oggi già occupati non è più solo fantapolitica. Mentre l’Azerbaijan, ha già dimostrato la sua aggressività nel Nagorno Karabakh. Alla luce di questo scenario, la vera domanda non è più “cosa vogliono fare gli Stati Uniti del Medio Oriente”, bensì: “come riusciranno a controllarlo?”.