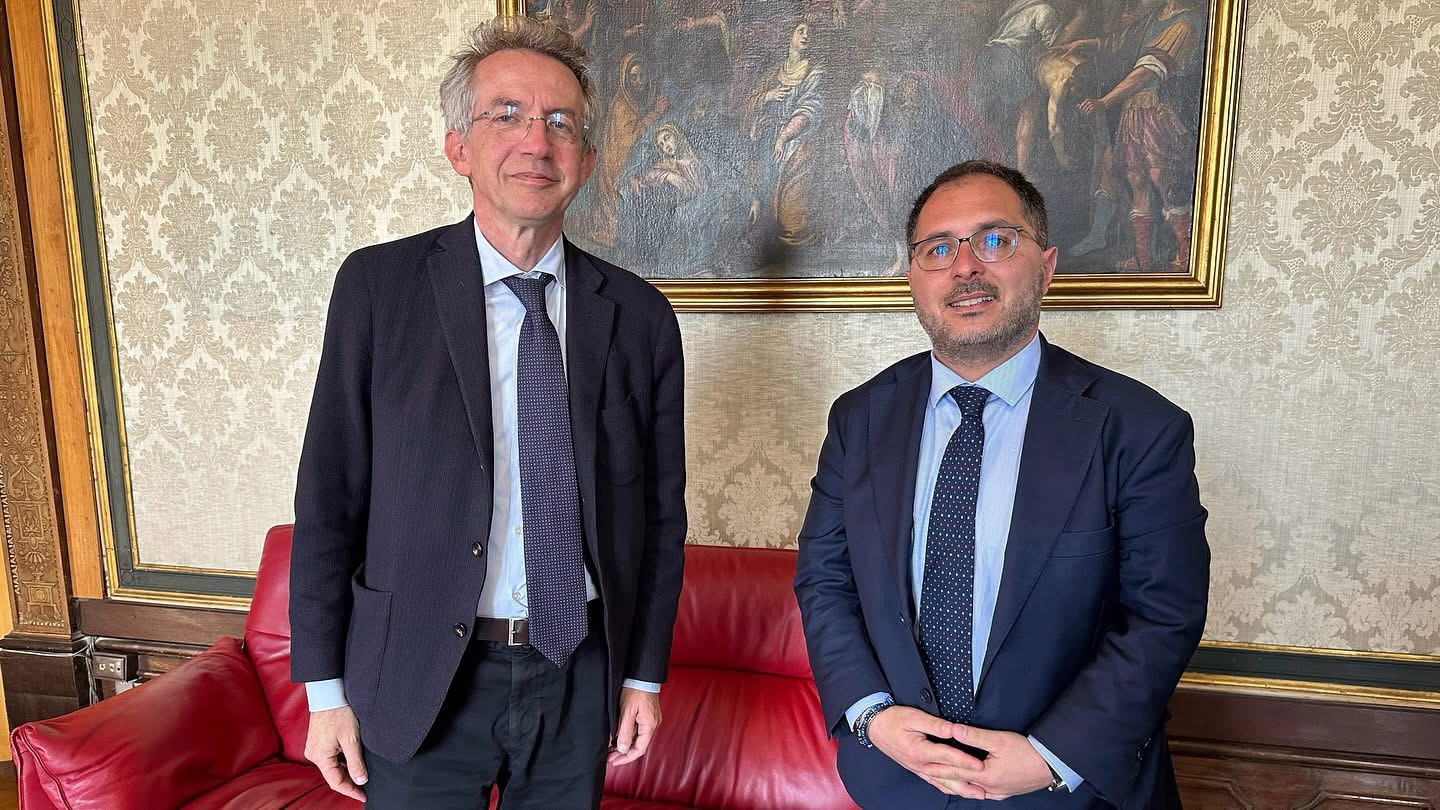di Alessandro Silvestri
Attivista Lgbtqia+ e dei diritti umani, dal carcere alle questioni umanitarie, al lavoro. Sofia Mehiel, le ragioni del tuo impegno?
«Intanto, il nome: “la Papessa”. Il cognome di famiglia è Papa e vista la difficoltà per molti nel pronunciare Mehiel, è nata la Papessa. Da sempre attivista nel mondo Lgbtqia+, ma attenta anche ad altre problematiche sociali e umanitarie. In Ucraina abbiamo consegnato a più riprese medicinali ed altro nella zona di Dnipro. Altro tema a me caro, quello del sostegno all’autodeterminazione delle donne islamiche contro il loro patriarcato. Vivo a Bologna da 31 anni e sono nata ad Avellino. Nel carcere di Reggio Emilia, mi occupo dei detenuti della sezione Orione e stiamo preparando dei progetti futuri anche per altre case circondariali con il focus principale del dopo detenzione, oltre che quello dell’assistenza a persone migranti con grosse vulnerabilità. Ma non si pensi che l’uso di un soprannome per quanto eccentrico, sia un vezzo, è invece un nome di battaglia in onore di Sylvia Lee Rivera (nata Rey Rivera) attivista ed icona newyorkese del movimento, nota in seguito ai fatti di Stonewall del 1969, che dettero il via al primo Gay Pride a Chicago nel 1970».
Secondo te il mondo del lavoro come recepisce oggi le nuove esigenze sui diritti della persona di scegliere la propria identità di genere?
«Il mondo del lavoro non si rende conto che il numero delle persone della comunità Lgbtqia+ è elevatissimo e lo sarà sempre di più, e allora non potrebbe essere una grande risorsa? Quindi trovo sia stupido il pensiero di stigmatizzare e allontanare questa grande comunità degna di rispetto. Sorrido quando qualcuno cerca ancora di discriminarci proponendoci soltanto lavori umili se non umilianti. Non sarebbe meglio istruire tutti per far sì che si possa poi trovare un punto di incontro? L’unica cosa che lamento è la mancanza di unione della comunità Lgbtqia+…troppe lettere e troppi pensieri spesso inefficaci invece di affrontare problemi concreti».
Come hai vissuto le aperture di Papa Francesco verso il mondo Lgbtqia+?
«Sono cattolica non praticante ed ho sempre amato la mia religione e ogni Papa naturalmente svolge il suo compito, anche in base alla sua sensibilità. Ma se si dichiara: “chi sono io per giudicare” e poi al tempo stesso si dice che l’omosessualità è un peccato, in un mondo dove siamo un po’ tutti peccatori, si creano in qualche modo nuove incomprensioni. In ogni caso ho provato un grande affetto per Papa Francesco».
Veniamo alla politica, come spieghi la scarsa o quasi inesistente partecipazione alla vita politica del “pianeta” Lgbtqia+?
«Ti rispondo che alle persone in genere, non interessa l’essere esposte in mostra su di uno scaffale. Hanno bisogno di fatti. Tutti dobbiamo lavorare, essere produttivi, amare la terra che ci dà la possibilità di sopravvivere nel rispetto del tutto, pagando le tasse in ossequio alle leggi. Quanto alla politica diretta, ho e abbiamo assieme alle altre compagne, come la brasiliana Alinny Batista, con le quali collaboro, frequentato un partito del centro sinistra su Bologna e il suo interland, ma abbiamo capito presto che il loro intento era quello di farci fare le belle statuine alle manifestazioni, senza nessun tipo di coinvolgimento istituzionale. In Brasile con il ritorno di Lula, sono entrate in Parlamento un certo numero di deputate trans e anche nei municipi, molte di noi sono coinvolte negli assessorati. È fondamentale per noi infrangere anche questo ulteriore muro. Però vedo anche scarso sostegno dal mondo gay, abituato da tempo ad avere maggiori concessoni. Mi sono e ci siamo avvicinate al PSI, per la grande tradizione di laicità e di sostegno delle minoranze di ogni tipo. Uno dei nostri obiettivi è avere leggi contro la Lgbt-fobia, di cui molti Paesi si sono già dotati, e di avere accesso diretto alla vita politica anche in Italia».
A proposito di carceri, qualcuno diceva che la civiltà di un Paese si misura nella qualità della vita dentro gli istituti di pena. A che punto siamo secondo te su questo tema?
«Ti posso dire che la situazione è abbastanza a macchia di leopardo. Il problema del sovraffollamento delle carceri determina problemi enormi proprio dal punto di vista della vita interna agli istituti. Il nostro lavoro all’interno della sezione del carcere di Reggio, dedicata alle trans, ci ha portato a sviluppare un modello che presto sarà diffuso anche in altre strutture. All’Orione abbiamo trovato una situazione di forte discriminazione anche razziale e di scarsissima attenzione per le esigenze delle detenute trans rispetto a quelle dei detenuti. A partire purtroppo dagli stessi operatori del carcere. Siamo riuscite a diminuire sensibilmente i casi di autolesionismo, che rappresentavano una vera e propria piaga quotidiana di umanità negata, anche se manca ancora una organizzazione delle attività quotidiane, da quelle formative a quelle puramente ricreative. Ad esempio è ancora impossibile avere uno spazio esterno semplicemente per prendere un po’ di sole. Per questo ci battiamo, affinché gli ultimi degli ultimi, possano conquistare quella dignità civile e sociale, troppo a lungo negata».